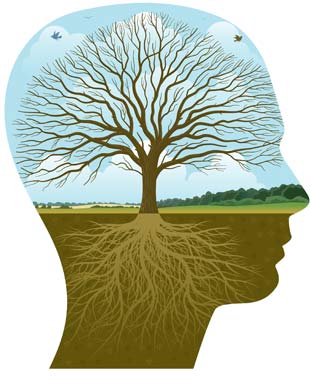
27 Ott Sbrogliarsela con la Psicoterapia – di Muriel Drazien e Marisa Fiumanò
Pubblicato in «Le journal», 1 (2001) della F.E.D.E.P.S.Y. di Strasbourg, dedicato a “Lo stato della psicanalisi e della psicoterapia in Europa”.
di Muriel Drazien-Marisa Fiumanò
L’articolo di Jean Yves Feberey e Simona Palmero ci dispensa dalle informazioni sulla nascita dell’Ordine degli Psicologi e sulla regolamentazione delle psicoterapie e ci permette di utilizzare questo spazio per aggiungere alcune riflessioni che riguardano più direttamente la psicanalisi.
Innanzitutto un po’ di storia interna: quando la legge Ossicini è stata approvata (legge 56 del febbraio ’89) le associazioni lacaniane in Italia non si sono organizzate per tentare di far sentire la propria voce, sia perché ritenevano che la legge non le riguardasse, sia perché non avevano sufficiente forza di pressione politica. Avevano scarsi contatti fra loro: la disseminazione di gruppi e associazioni che si richiamavano all’insegnamento di Lacan, ma senza riferimenti né organi di rappresentanza comuni, rendeva ininfluente il loro peso culturale e politico. Questo non impediva che i testi di Lacan penetrassero nelle Università, che fossero utilizzati e citati da filosofi e scrittori, ma senza che gli analisti fossero invitati a discuterne o interpellati in proposito. L’establishment culturale, che in Italia troppo spesso coincide con quello universitario, ha sempre sbarrato il passo alla clinica e ai clinici e se oggi comincia ad aprire qualche porta lo fa preferibilmente nei confronti di coloro che trattano l’insegnamento di Lacan come un discorso universitario. All’epoca dell’approvazione della legge Ossicini mancavano dunque le condizioni minime per tentare un’opposizione.
La SPI (Società Italiana di Psicoanalisi, affiliata all’IPA) dal canto suo, attraverso accordi informali, aveva ottenuto che nel testo della legge Ossicini la psicanalisi non fosse menzionata affatto. Un escamotage per salvare la forma visto che, al tempo stesso, gli allievi in formazione erano sollecitati a frequentare le scuole di specializzazione. Dal momento di entrata in vigore della legge, infatti, chi esercitava senza un diploma di specializzazione, rischiava di essere denunciato per esercizio abusivo della professione . Da qui la necessità di creare proprie scuole di specializzazione per evitare che i propri allievi frequentassero quelle di altre associazioni. Alcuni membri della SPI presentavano dunque domanda di riconoscimento alla apposita Commissione Ministeriale.
Le scuole riconosciute in prima battuta erano relativamente poche, circa una ventina, spartite tra freudiani, junghiani, comportamentisti, cognitivisti, lacaniani (una sola scuola lacaniana, immediatamente riconosciuta, con sede a Roma e sotto la direzione scientifica di Jacques-Alain Miller) e qualche altro oscuro indirizzo “terapeutico”. Per molti anni il loro numero è rimasto invariato, malgrado le ulteriori richieste di riconoscimento avanzate nel frattempo da parte dei gruppi meno tempestivi e accreditati politicamente e istituzionalmente.
Presto le Scuole si sono rivelate un discreto business sia perché il loro costo era piuttosto alto ( un minimo di quattro milioni annui motivato delle molte ore di insegnamento e di “supervisione” clinica rivolte ad un numero contenuto di allievi), sia perché assicuravano un numero di domande di formazione personale corrispondente al numero degli allievi.
Le vicende politiche esterne (caduta del Governo Berlusconi del ‘95) hanno rallentato il lavoro (da più parti criticato) della Commissione, non senza soddisfazione da parte di chi, al suo interno, sponsorizzava questa o quella Scuola e tendeva quindi a contenere il numero di riconoscimenti delle altre. Nel frattempo scoppiava una violenta contestazione sostenuta dall’Ordine degli Psicologi che criticava l’interpretazione di un articolo della Legge secondo la quale solo le Università, e non le associazioni private, sarebbero state autorizzate a creare scuole di specializzazione. In quell’occasione ebbe partita vinta l’Ordine degli Psicologi che ormai contava alcune decine di migliaia di iscritti sfornati come funghi dalle sempre più numerose Facoltà di Psicologia e che sosteneva i diritti delle scuole private.
Si arriva così al decreto n.° 509 del dicembre ’98 che autorizza la creazione di scuole di specializzazione sia pubbliche che private. Viene nominata una nuova commissione ministeriale che appare più equanime nella valutazione dei requisiti richiesti nel senso che, tendenzialmente, si attiene a quelli formali ( numero delle ore, qualifiche dei docenti, idoneità dei locali e delle attrezzature, possibilità per gli allievi di effettuare i tirocini). Nel frattempo l’Ordine degli Psicologi aveva presentato come una grande vittoria l’essere riuscito a rendere fiscalmente deducibili le spese per la psicoterapia e ad equipararle a quelle mediche, esenti dall’IVA . La manovra, oltre ad assicurare introiti sicuri alle casse dello Stato, rendeva ancora più difficile ai non-medici rinunciare al titolo di psicoterapeuta: chi non ne era in possesso si sarebbe infatti trovato nell’imbarazzante situazione di dover rifiutare al “cliente” la fattura relativa ai costi delle sedute, fiscalmente detraibile.
Da tutta questa diatriba giuridico-fiscale i gruppi lacaniani (milleriani a parte) si sono chiamati fuori fino a quando è apparso evidente che le domande di formazione andavano diminuendo e che chi era sul punto di autorizzarsi come analista non avrebbe potuto lavorare tranquillamente, visto che la sua professione era giuridicamente inesistente, dunque denunciabile. Questa preoccupazione non coinvolgeva i medici che, in quanto tali, non correvano rischi.
Quest’ultimo intervento dello Stato a proposito di ciò che è rimborsabile o no come atto professionale sottolinea ancora di più il buco di questa legge rispetto alla psicanalisi. Non nominandola la legge respinge la psicanalisi nei suoi stessi confini, in un “che cosa abbiamo a che fare con la psicoterapia?” e rigetta la psicanalisi laica ( ma ne esiste una che non lo sia?) fuori legge.
In questa complessa situazione, e non senza conflitti, è stato fondato il “Laboratorio Freudiano per la formazione degli psicoterapeuti”, emanazione di “Cosa Freudiana”, che ha presentato al Ministero della Ricerca Scientifica regolare domanda di riconoscimento. Questo passo, compiuto nel 1994, è rimasto senza esito per sette anni: il riconoscimento della scuola è stato ostacolato da rinvii pretestuosi e apparentemente incomprensibili. Finché, nella primavera di quest’anno, è arrivato il decreto ministeriale di autorizzazione e, dal prossimo anno accademico, il “Laboratorio Freudiano” entrerà in funzione.
Dalla fine degli anni ottanta ad oggi, malgrado l’intensità e ,in alcuni casi, la qualità del lavoro svolto dalle diverse associazioni lacaniane presenti in Italia, è mancata la collaborazione, e quindi la forza, necessarie a sostenere pubblicamente il significante psicanalisi. Per il grande pubblico è un termine che si confonde con quello di psicoterapia e, più che sparire, ne è diventato un sinonimo.
Ancora oggi è difficile pubblicare un libro che si richiama all’insegnamento di Lacan a meno di non usare qualche esca che lo renda appetibile per l’editore o garantendo un certo numero di copie vendute. Le scuole di specializzazione servono anche a questo, a creare un mercato editoriale, quindi la circolazione sociale di un discorso altrimenti limitato ad una cerchia di pochi.
E allora? Affiancare alla formazione degli analisti quella degli psicoterapeuti è una scelta obbligata? Crediamo che oggi in Italia non si possa fare altrimenti anche se l’impresa non è esente da rischi e paradossi, alcuni dei quali appaiono già evidenti e sono all’origine della recente scissione avvenuta all’interno della “Scuola europea di psicoanalisi” diretta da J.-A. Miller. Se l’unico esito possibile fosse quello di contrabbandare il discorso universitario come discorso psicanalitico non varrebbe nemmeno la pena di tentare l’impresa. Che cosa sapremo fare di diverso, attenendoci all’etica a cui siamo stati formati, potremo valutarlo solo a posteriori.
Adesso, costretti come siamo da avvenimenti ai quali, benché previsti, abbiamo preferito non attribuire il peso necessario, non ci resta che riaprire il dibattito all’interno delle associazioni psicanalitiche, ad esempio ponendo la questione se non si possa parlare che di psicanalisi laica o in che cosa potrebbe consistere un insegnamento per l’esercizio della psicoterapia oppure di che senso abbia il desiderio di guarire.


