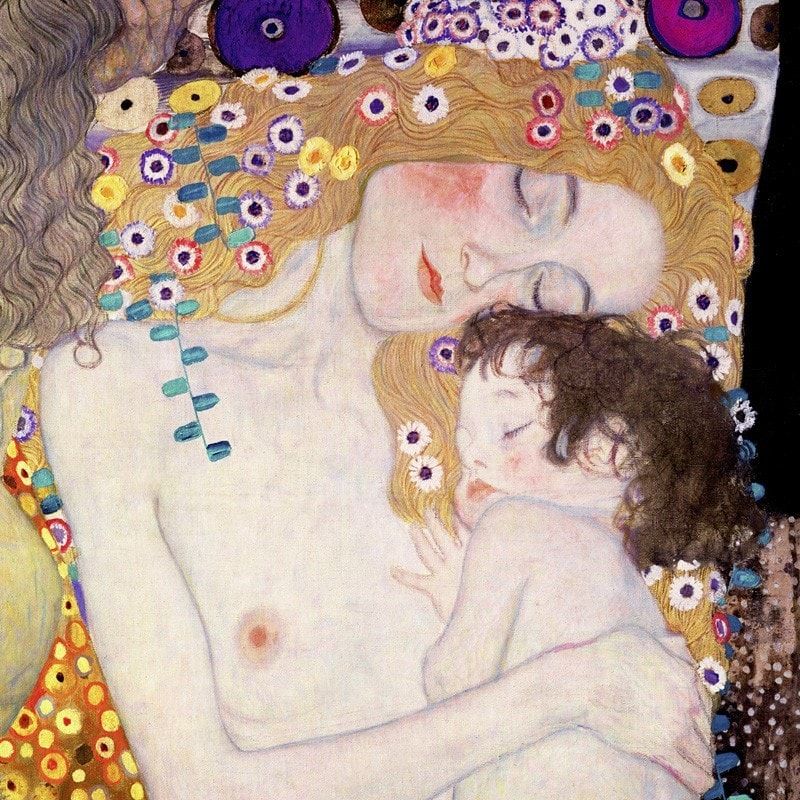
06 Apr I tre tempi dell’Edipo (I) – Seminario V – Le formazioni dell’inconscio
Carmen Gurnari
I TRE TEMPI DELL’EDIPO (I)
Seminario V – Le formazioni dell’inconscio Capitolo X
Continuo con la lettura di quei capitoli del V Seminario Le formazioni dell’inconscio che ho proposto come approfondimento della Questione preliminare. Siamo al X capitolo dedicato ai tre tempi dell’Edipo.
Nel capitolo precedente, dopo aver discusso l’insufficienza delle formule di cui ci si serve in campo analitico per definire la funzione del padre, Lacan è arrivato ad identificare la possibilità di articolare il complesso di Edipo e la sua molla, vale a dire la castrazione, nella struttura della metafora.
Per arrivare a questo è indispensabile ragionare in termini di soggetto che non va confuso con la realtà individuale che si ha davanti. Il soggetto è introdotto dalla parola, basta che si parli per evocare qualcos’altro, per questo Lacan si chiede: “La parola è forse come una emanazione che fluttua al di sopra di lui, o invece sviluppa, impone in se stessa, una struttura…?” (p.181).
Basta che si parli perchè sorga “un terzo”, il grande Altro costituente della posizione del soggetto in quanto parla.
I paragrafo
L’anno precedente, nel IV seminario dedicato alla relazione d’oggetto, Lacan aveva introdotto un triangolo immaginario (madre-bambino-fallo) per disegnare il rapporto madre-bambino, vale a dire per rappresentare il primo rapporto di realtà, quello in cui, cito: “il bambino prova le prime realtà del suo contatto con l’ambiente vivente”.
A questo punto è però necessario introdurre il padre, cito: “E’ allo scopo di disegnare obiettivamente la situazione che facciamo entrare il padre nel triangolo, quando per il bambino non c’è ancora entrato. – … ammettere come fondamentale il triangolo bambino-padre-madre è, senza dubbio, apportare qualcosa che è reale ma che nel reale, pone già, intendo dire come istituito, un rapporto simbolico” (p.182).
Dunque, perchè possa porsi qualcosa di reale occorre che si istituisca un rapporto simbolico, e da questo momento abbiamo a che fare con un “oggetto”.
Notiamo come si disegni qui il rapporto tra simbolico e reale, il primo fonda il secondo e non il contrario, passando attraverso l’istituzione dell’obiettività. Dunque il padre, in quanto funzione simbolica, fonda l’oggettività, proprio nel senso di “produrre un oggetto”, ricordiamo l’etimologia: “ob-iectum” = posto di fronte, qualcosa che, per potersi porre di fronte, si deve staccare…
Ma in che modo il padre sarebbe il garante di questo processo? Può esserlo solo nella misura in cui, in posizione di significante, va a sostituire la madre nella
relazione primordiale che li lega.
In posizione di significante, dunque il padre che per noi è reale lo è in quanto le istituzioni gli conferiscono non solo il ruolo e la funzione di padre ma piuttosto, il nome.
Che il padre sia il vero agente della procreazione non è, del resto, una verità d’esperienza diretta, che sul piano biologico sia necessaria una certa sequenza di eventi può non essere evidente ed a lungo non lo è stato. Non a caso negli anni della prima psicoanalisi quando, dice Lacan: “ancora si discuteva di cose serie…”, si era notato che in una certa tribù primitiva la procreazione veniva attribuita cito: “ad una qualunque cosa, una fontana, una pietra o l’incontro con uno spirito in luoghi appartati” (p.182). Ciò nonostante Jones notava che era impensabile che degli esseri intelligenti, sebbene primitivi, non si rendessero conto del nesso con l’accoppiamento. Come che sia, ciò che importa non è che si sappia o meno che una donna possa partorire soltanto dopo un coito, ma è necessario sancire in un significante il fatto che
colui con il quale la donna ha avuto il coito è il padre.
Non è la sequenza di eventi tanto differenti come un coito ed un parto a stabilire la paternità, ma la qualifica del padre come procreatore, cito: “è un affare che si situa a livello del simbolico” in quanto non si tratta che di un nome, il Nome del padre.
Esso si realizza in diverse forme culturali ma è una necessità della catena significante. Vale a dire che, per il solo fatto di istituire una catena significante, cioè di entrare in un ordine simbolico cito: “qualcosa risponde oppure no alla funzione definita del Nome del padre” (ivi) . All’interno di questa funzione si potranno mettere significazioni differenti ma che sempre verranno a dipendere dalla necessità della funzione del padre.
A partire dall’articolazione di una parola, cioè da quando c’è catena significante, si istituisce nel reale il ternario simbolico e c’è relazione tra questo ternario e quello immaginario che rappresenta lo stretto legame tra il bambino e la madre o meglio tra il bambino e il desiderio della madre come prima simbolizzazione.
Questa prima simbolizzazione consiste nel porre la madre come quell’essere primordiale che può esserci o non esserci. E’ questa alternanza in cui il non esserci sorge sullo sfondo dell’esserci e viceversa l’esserci emerge sullo sfondo del non esserci, ad aprire la possibilità fondamentale di quell’essere o non essere che tormenta Amleto.
Perchè è solo così, dice Lacan, che: “il bambino distacca la sua dipendenza effettiva dal desiderio della madre, dal puro e semplice vissuto di questa dipendenza, e si trova istituito qualcosa che è soggettivato a un livello primario o primitivo” (p.183-184).
Si tratta di una prima soggettivazione perchè il soggetto si ritrova sottomesso, “assoggettato” dirà poi Lacan, a questa presenza-assenza. Ma perchè questa alternanza sposta il bambino dalla condizione di immersione nel semplice vissuto? Perchè se la madre può essere presente o assente vuol dire che qualcos’altro la occupa, qualcosa che non è il bambino, ecco allora che si apre uno spazio terzo, qualcosa di oggettivo che si colloca tra i due.
Non si tratta dunque delle semplici cure della madre intese come accudimento,
come indispensabile sostegno per la sopravvivenza del neonato, ma dell’effetto psichico della di lei presenza ed assenza, come possiamo chiamare questo? Lo chiamiamo desiderio. Il desiderio della madre che apre quello del bambino.
La madre è un essere desiderante perchè vive nel simbolico, è nel linguaggio e il bambino desidera il desiderio della madre. E’ questo che dischiude per lui un mondo.
Dice Lacan: “Di conseguenza si schiude una dimensione in cui si iscrive virtualmente ciò che la madre desidera oggettivamente in quanto essere che vive nel mondo del simbolo, in un mondo in cui il simbolo è presente, in un mondo che parla” (p.184).
“Oggettivamente” vi prego di soppesare le parole che in Lacan non sono mai scelte a caso. Ed ancora: “…questa simbolizzazione primordiale apre al bambino la dimensione di ciò che la madre può desiderare di altro, come si dice, sul piano immaginario“(ivi).
E compare la dimensione dell’Altro sotto la forma di Altra cosa, quell’Altra cosa che abbiamo incontrato nella lezione precedente, la stessa che Lacan nomina nella Questione preliminare tra i modi di manifestarsi dell’inconscio.
Il desiderio di Altra cosa fa il suo ingresso, cito: “in modo confuso e del tutto virtuale…in modo concreto. In lei (la madre) piuttosto che soddisfare il mio desiderio che comincia a palpitare alla vita, c’è il desiderio di Altra cosa” (ivi).
Ecco la dimensione dell’inconscio che si schiude per il piccolo dell’uomo, è la madre che lo “insegna”, ella desidera ed è così che può aprirsi il desiderio del nuovo arrivato, ma può farlo grazie all’esistenza del padre in latenza, più propriamente del nome del padre.
Lacan lo descrive così: “A questo percorso c’è, contemporaneamente, accesso e non accesso. In questo rapporto di miraggio – per cui l’essere primo legge o anticipa il soddisfacimento dei suoi desideri nei movimenti abbozzati dell’altro, in questo adattamento duale dell’immagine all’immagine, che si compie in ogni relazione interanimale – come concepire che possa esservi letto come in uno specchio, così si esprimono le Scritture, ciò che il soggetto desidera d’Altro?” (ivi).
Ecco legato il desiderio e l’Altro.
Nella difficoltà di questo complesso e delicato meccanismo di corrispondenza si colloca la perversione come modalità difettosa ma tuttavia realizzata. Quello che non deve mai mancare, dice Lacan: “è l’intervento di qualcosa di più della simbolizzazione primordiale della madre che va e che viene, che si chiama quando non c’è e che quando c’è, si respinge per poterla poi richiamare” (ivi).
Si tratta della presenza, dietro la madre, dell’ordine simbolico da cui ella dipende e che è ciò che permette, cito: “un certo accesso all’oggetto del suo desiderio, che è già un oggetto talmente specializzato, talmente segnato dalla necessità instaurata dal sistema simbolico che sarebbe assolutamente impensabile in altro modo nella sua incidenza” (p.185).
Insomma, perchè il meccanismo speculare possa entrare in gioco deve essere già instaurato l’ordine simbolico che, come sappiamo, è l’ordine dello scambio, della sostituibilità. La sostituibilità è del significante ma il significante ha a che fare con il desiderio e dunque rimanda al suo oggetto ed è di questo oggetto “necessario” e
“specializzato” che Lacan parla a questo punto. Oggetto e significante possono apparire nella teoria come due concetti eterogenei, eppure essi, nella simbolizzazione, trovano un punto di snodo.
Questo punto di snodo si chiama: “fallo”, il fallo è un elemento cruciale della teoria che chiama in gioco sia l’Immaginario che il Simbolico.
Infatti il fallo è un oggetto ma è anche un significante, l’incidenza dell’oggetto sarebbe impensabile se non in quanto oggetto del desiderio della madre già instaurato dalla necessità dell’ordine simbolico. Si tratta, dice Lacan, di un oggetto “privilegiato” e questo privilegio è una necessità del Simbolico stesso.
Notiamo che nel disegno dei due triangoli, quello detto “immaginario” del IV seminario (Relazione d’oggetto) e quello simbolico del V (Formazioni dell’inconscio), che disegnano la relazione madre bambino, le due posizioni di vertice, che possiamo considerare simmetriche, sono occupate, rispettivamente, dal fallo e dal padre. Non si tratta di semplice simmetria, precisa Lacan, ma di legame, di un legame che è di ordine metaforico. Ed è proprio questo che ci conduce alla dialettica del complesso di Edipo dove non tutto è poi così chiaro.
Condurre passo passo questo discorso ci consente di vedere come – cito: “la posizione del significante del padre nel simbolo sia fondatrice della posizione del fallo sul piano immaginario” (ivi), si tratta di arrivare a distinguere i tempi logici della costituzione del fallo sul piano immaginario come oggetto privilegiato e prevalente e di distinguerne, concettualmente, l’azione simbolica.
Il desiderio della madre è il desiderio dell’Altro nella sua forma primordiale che comporta, apre, un “al di là”. Per raggiungere questo al di là (peraltro irraggiungibile) occorre una mediazione e, cito: “questa mediazione è precisamente data dalla posizione del padre nell’ordine simbolico” (p.186).
Ci sono delle tappe precoci in cui il bambino si identifica con il fallo in quanto oggetto dell’al di là del desiderio della madre, questo è stato trattato nel corso del IV Seminario. Le perversioni sono il campo privilegiato in cui osservare questo. Ci sono casi in cui il soggetto si lega in modo particolare con questo oggetto per via di un’ identificazione immaginaria con la madre, è la perversione più esemplare: il feticismo. Altri casi sono quelli del travestitismo in cui più che identificarsi, come viene detto, con la madre fallica, il soggetto si identifica con il fallo – cito: “in quanto nascosto sotto le vesti della madre” (ivi).
Inoltre, aggiunge Lacan, questo ha un ruolo nel rapporto che il bambino ha con la coppia genitoriale, lo abbiamo visto nel capitolo precedente a proposito dell’Edipo detto “rovesciato” in cui il bambino, identificandosi con la madre, si trova ad assumere, più comodamente, una posizione passiva nei confronti del padre trovandosi però, in questo modo, esposto alla condizione della privazione del suo organo virile.
L’esperienza analitica insegna che il padre, non in particolare nelle perversioni, ma in tutte le nevrosi ha un ruolo essenziale proprio come colui che priva la madre dell’oggetto del suo desiderio, l’oggetto fallico. Vale a dire che il padre è un agente privatore, un agente causa di privazione.
C’è però da intendersi a proposito della privazione, perchè – cito: “il padre non castra la madre di qualcosa che lei non ha, bisogna che quello di cui si tratta sia già proiettato sul piano simbolico in quanto simbolo” (p.187).
Si tratta di una privazione reale che richiede la simbolizzazione (passaggio dalla cosa al significante – gioco del rocchetto).
E’ questo un punto ineludibile nella storia di ogni soggetto, ci dice Lacan: “nell’esperienza troverete sempre che il soggetto ha preso posizione in un certo modo, in un dato momento della sua infanzia rispetto al ruolo che il padre ha per il fatto che la madre non ha il fallo. Questo momento non è mai eliso” (p.186).
Nella privazione qualcuno viene privato di quel che non ha (ricordiamo l’aforisma dell’amore: amare è donare quel che non si ha), cioè di qualcosa che non ha esistenza se non nella misura in cui accede all’esistenza in quanto simbolo.
E’ questa l’operazione del padre, simbolica (castrazione) in quanto basata su una privazione che è reale, ed ogni soggetto nell’evoluzione dell’Edipo deve confrontarsi col fatto di accettare o meno questa privazione, il che significa riuscire o meno a rendere significante la privazione di cui la madre risulta essere l’oggetto.
Questo punto è essenziale sebbene non coincida con quello di cui cerchiamo la chiave, cioè l’esito del complesso di Edipo, vale a dire il suo frutto, cioè l’identificazione del bambino con il padre. Qui si tratta di un momento anteriore di intervento del padre che entra in gioco come colui che priva la madre.
Dunque, dietro il rapporto della madre con l’oggetto del suo desiderio si profila colui che castra, come si vede qui ad essere castrato non è il soggetto ma la madre. La castrazione ha a che fare con l’istituzione del limite ma anche con la separazione, il taglio. Del resto, senza perdita, come potrebbe sorgere il desiderio?
In altri termini detto si tratta di quel processo di alienazione-separazione che è alla base dell’individuazione.
Se il bambino non accetta questo, non oltrepassa questo punto nodale, dice Lacan, vale a dire non accetta la privazione del fallo operata dal padre sulla madre (le postazioni devono essere due) ciò significa che manterrà una certa forma di identificazione con l’oggetto della madre, oggetto che si presenterà allora come un oggetto-rivale, questo che si tratti di fobia, di nevrosi o di perversione.
Abbiamo dunque a che fare con un punto di repere per la clinica e Lacan si chiede: “qual’è la configurazione speciale del rapporto con la madre, con il padre, con il fallo, per cui il bambino non accetta che la madre sia privata dal padre dell’oggetto del suo desiderio? (p.188). Possiamo correlare tutto questo al fatto che egli tenda a mantenere la sua identificazione col fallo?
Ci sono in questo dei gradi diversi, questo rapporto non è lo stesso nelle diverse forme cliniche: nevrosi, psicosi, perversione.
Possiamo dire che sul piano immaginario la questione si pone al soggetto in questa forma: essere o non essere, to be or not to be, il fallo?
Naturalmente si tratta di una libera scelta per modo di dire, perchè non è semplicemente il soggetto a scegliere, cito: “non è lui a tirare le fila del simbolico. La frase cominciata prima di lui è stata iniziata dai suoi genitori” (ivi).
Quello che conta è il rapporto di ciascun genitore con la frase cominciata e l’importanza della posizione reciproca che i genitori hanno tra di loro rispetto a questa frase. Dice Lacan: “c’è lì al neutro, un’alternativa tra essere e non essere il fallo” (ivi). La questione del transgenerazionale affonda qui la sua pregnanza.
Tra l’essere e l’avere, o meglio: l’ “averne o no” c’è il complesso di castrazione.
Afferma Lacan: “ciò di cui si tratta nel complesso di castrazione non è mai articolato, e si fa quasi completamente misterioso. Eppure sappiamo che è proprio da esso che dipende il fatto che un maschietto diventi un uomo e una femminuccia una donna“(ivi).
E’ dunque il complesso di castrazione, in entrambi i sessi, che regola la possibilità di averlo, anche per chi, alla fine, dovrà averlo, cioè il maschietto, e Lacan precisa: “La qual cosa suppone che, per averlo, bisogna che ci sia stato un momento in cui egli non lo aveva. Non lo si chiamerebbe complesso di castrazione se non fosse necessario, per poterlo avere, stabilire che non lo si può avere, sicchè la possibilità di essere castrato è essenziale nell’assunzione del fatto di avere il fallo. E’ un passo da compiere dove il padre deve intervenire in qualche momento, in modo efficace, reale, effettivo” (traduz. modificata p.188-189).
Insomma mi pare che se ne possa concludere che il desiderio dell’Altro, del primo grande Altro la fa da padrone ma lo fa sotto un profilo particolare, quello della castrazione…
II paragrafo
Riassumendo: nella prima fase si tratta per il soggetto, uomo o donna che sia, di essere o non “essere il fallo”, il passo successivo è quello di “averlo” o “non averlo” e per questo bisogna che il padre intervenga in modo effettivo, consideriamo allora il suo intervento più da vicino.
Innanzitutto è necessario che egli sia, al di fuori del soggetto, costituito come simbolo, se questo non è, dice Lacan: “nessuno potrà realmente intervenire rivestito di questo simbolo. E’ in quanto personaggio reale rivestito di questo simbolo che il padre potrà intervenire nella tappa successiva” (p.189).
Il padre ha un ruolo fondamentale nella proibizione, tuttavia non è indispensabile per le interdizioni delle prime manifestazioni sessuali del bambino, basta la madre. Il piccolo Hans quando, trovandosi in una posizione ancora molto vicina a quella di identificazione immaginaria con il fallo, si mostra alla madre offrendole i servigi del suo piccolo pene, viene redarguito subendo così una svalutazione immaginaria che basta per interdire l’uso del suo nuovo strumento.
Di certo tutto questo è possibile in quanto esiste, sullo sfondo, il padre come portatore della legge e la legge fondamentale è l’interdizione dell’ incesto, tuttavia non occorre che il padre promulghi effettivamente questa proibizione come legislatore ex-cathedra.
Afferma Lacan: “egli fa da ostacolo tra il bambino e la madre, è il portatore della legge, ma di diritto, mentre di fatto interviene altrimenti ed è altrimenti che si manifestano le sue mancanze a livello d’intervento” (p.190).
Il punto più delicato è quello dell’uscita dal complesso che ne rappresenta il punto chiave.
Lacan disegna a questo proposito in forma ridotta, essenziale, il grafo che
ha sviluppato nella prima parte del seminario, cito: “è solo dopo aver attraversato l’ordine simbolico, fin da subito costituito, che l’intenzione del soggetto, cioè il suo desiderio passato allo stato di domanda, incontra ciò a cui è indirizzato, il suo oggetto, il suo oggetto primordiale, vale a dire la madre” (ivi).
Ricordiamo che può esserci desiderio perchè c’è parola, il mondo in cui il nuovo soggetto si addentra ed avanza non è semplicemente una Umwelt, cioè un luogo dove poter saturare i propri bisogni, ma, cito: “è un mondo in cui regna la parola che sottomette il desiderio di ciascuno alla legge del desiderio dell’Altro” (ivi).
La catena significante è già lì, latente, ed il soggetto che la incontra strutturala sua domanda, la prima prova con l’Altro il soggetto la fa simbolizzando questo primo grande Altro che è la madre. Il Fort – Da come prima articolazione, dimostra che è proprio in quanto l’intenzione ha attraversato la catena significante divenendo domanda che essa può farsi valere presso l’oggetto materno.
Questa prima simbolizzazione (presenza-assenza) costituisce la madre come soggetto ma, al contempo, sottomette il nuovo nato a quella che diventerà la legge. Dice Lacan: “E’ solo una metafora. Bisogna schiudere la metafora contenuta in questo termine, la legge, per darle la sua vera posizione…” (p.191). Se di legge si tratta, dal momento che la madre è un essere parlante e dunque c’è articolazione, legge della parola, è però una legge ancora
incontrollata, è la legge della madre. Come vediamo si tratta di una lettura più specifica di quella madre buona e madre cattiva che, a partire dalla Klein domina la psicoanalisi così detta “oggettuale” (Winnicott ecc).
Si tratta di legge per il soggetto in quanto si sostiene sul fatto che qualcosa del suo desiderio è completamente dipendente da qualcos’altro di articolato, tuttavia questa legge risiede interamente nel soggetto che la supporta.
La psicoanalisi si è interrogata a lungo sul bambino, si è chiesta se per lui ci sia realtà o non realtà, autoerotismo o non autoerotismo, Lacan riformula la questione ponendo il bambino, cito: “come soggetto, come colui da cui proviene la domanda e colui in cui si formula il desiderio – e tutta l’analisi è una dialettica del desiderio” (ivi).
In tutto ciò il bambino è del tutto assoggettato, è un “assoggetto” dice Lacan: “si sperimenta e si sente innanzitutto assoggettato al capriccio da cui dipende, anche se questo capriccio è un capriccio articolato” (ivi).
E’ il famoso capriccio della madre.
Il soggetto si barcamena come può in questa condizione di assoggettamento, il complesso di Edipo ed il suo tramonto sono un modo di barcamenarsi. E ancora una volta Hans ci insegna qualcosa, la sua uscita dall’Edipo è “atipica”, si configura come una supplenza.
Egli ricorre dice Lacan: “al cavallo tuttofare per supplire a quanto gli
manca nel momento del superamento, che non è altro che quella tappa dell’assunzione del simbolico come complesso d’Edipo” (p.192).
Il cavallo è il padre, il fallo, la sorellina. Se ripensiamo all’ultimo sogno vediamo come Hans ne esce, cioè come avviene questo superamento. Al posto del padre egli ricorre a quella figura immaginaria ed onnipotente che è l’idraulico.
Se l’angoscia di Hans è angoscia d’assoggettamento, l’idraulico è lì per disassoggettare. Nell’assoggettamento non si sa dove si va a finire, si sperimenta un senza-limite (senza rappresentazione) cui corrisponde l’angoscia, allora la strategia è creare dei centri di paura attorno ai quali ruoterà il ripristino della sicurezza del soggetto. Sembra un paradosso eppure è con la paura che il bambino si rassicura.
Dopo tutto la paura di qualcosa, in quanto legata ad una rappresentazione (ad esempio la carrozza che se ne va) è una paura definita, limitata, ancorata a qualcosa da cui il soggetto si può guardare, qualcosa che può tenere a distanza. E’ una condizione diversa da quello stato diffuso e senza nome che chiamiamo angoscia dentro cui ci si può ritrovare a cadere.
Dice Lacan: “grazie alle sue paure egli dà un al di là a quell’assoggetatamento angosciante che realizza nel momento in cui appare la mancanza del dominio esterno…Perchè non sia puramente e semplicemente un assoggetto, è necessario che appaia qualcosa che gli faccia paura” (ivi).
Già Freud aveva descritto in questi termini la psicodinamica della fobia, non a caso il piccolo Hans è stato considerato un caso emblematico ed anche nella peculiare teorizzazione che Lacan fa del soggetto, come un “assoggetto”, la paura si presenta al servizio della soggettivazione come argine all’assoggettamento.
L’Altro materno però non è l’unico protagonista sulla scena, esso è preso in un certo rapporto col padre dal momento che la duplicità delle istanze in gioco è essenziale, altrimenti non si potrebbe avere il ternario.
Non si tratta soltanto di una “rivalità di prestigio” che converge sul bambino, tutto questo è veridico ma non sufficiente se la psicoanalisi vuole aggiungere al punto di vista sociologico-ambientalistico qualcosa di più, qualcosa di specifico della sua ottica.
Il legame d’amore, il rispetto ad esempio della madre per il padre (nel caso di Hans ci si è chiesti ad esempio: la madre era sufficientemente affettuosa con il padre? aveva stima per lui?) non è l’essenziale, quello che conta non è il rapporto della madre come persona con la persona del padre ma il rapporto della madre con la parola del padre.
L’importante è, cito: “che la madre fondi il padre come mediatore di ciò che è al di là della sua propria legge e del suo capriccio, vale a dire puramente e semplicemente della legge come tale” (ivi). Insomma deve prendere consistenza un al di là della madre di cui è lei stessa a riconoscere la parola del
padre come mediazione. Ed il bambino dovrà accettare il padre come colui che priva o che non priva la madre dell’oggetto del suo desiderio.
Per comprendere il complesso di Edipo, secondo Lacan, abbiamo bisogno di tre tempi.
III Paragrafo
Andiamo allora a considerare questi tre tempi.
Primo tempo.
Lacan riprende il grafo del desiderio perchè il desiderio è in posizione di rilievo nella partita che andiamo a descrivere, cioè quella edipica.
Abbiamo detto che ad essere in gioco nella prima fase è l’essere: il to be or not to be, propriamente si tratta, per il nuovo nato, di tentare di essere l’oggetto del desiderio della madre. Vale a dire che il desiderio del bambino è di poter soddisfare il desiderio della madre, quello di cui egli è alla ricerca è un desiderio di desiderio.
Dice Lacan: “Egli introduce dunque la sua domanda, qui, in delta, il cui frutto apparirà là, in delta primo” (p.193). Delta e delta primo sono i due punti, rispettivamente di partenza e di arrivo della linea curva del grafo, cito: “in questo cammino il punto che corrisponde all’ego si trova di fronte a quello che è qui il suo altro, con cui egli si identifica, quel qualcosa di altro che cercherà di essere e cioè l’oggetto che può soddisfare la madre” (ivi).
Si vede bene come la costituzione dell’oggetto inteso come simile, come piccolo altro, altro della fase dello specchio che regge l’identificazione immaginaria, osservato più da vicino nella dinamica edipica, si complessizzi diventando, in quanto oggetto del desiderio della madre, un oggetto simbolico sotteso da quella x che apre l’identificazione madre-bambino ad un al di là mettendo in moto il meccanismo simbolico.
Per questo Lacan, a proposito di Hans, può osservare: “appena comincerà a smuoversi qualcosa nel suo basso ventre, comincerà a mostrarlo alla madre, per sapere se – sono capace di qualche cosa -, con le delusioni che ne conseguono” (ivi).
Qui il bambino cerca di segnalarsi al suo primo grande Altro, di verificare se può soddisfarlo o meno, se davvero può coincidere con quello che gli manca (l’oggetto del suo desiderio), ma anche la madre è interrogata dalla domanda del bambino in quanto lei stessa è, cito: “all’inseguimento del proprio desiderio” (ivi).
Essere nel linguaggio significa aver perso la “cosa”, e doverla ricercare per le vie del significante, vale a dire essere abitati da una mancanza, una mancanza d’essere che chiama risposta, da qui la domanda e la spinta del desiderio. Tutto questo vale per la madre ed occorre che si apra anche per il nuovo nato, bisogna cioè che questa mancanza “passi” al bambino, solo così egli potrà divenire un soggetto, ma per far questo egli deve compiere tutto un percorso che è quello dell’Edipo, passando attraverso l’assoggettamento che abbiamo descritto.
In questo primo tempo per il bambino si tratta dunque di identificarsi
specularmente con ciò che è l’oggetto del desiderio della madre. E’ la prima tappa, quella fallica primitiva in cui al bambino basta essere il fallo della madre, egli non ne coglie che questo frutto, tuttavia la metafora paterna è già in azione, ci dice Lacan: “la metafora paterna agisce in sè nella misura in cui è già instaurato nel mondo il primato del fallo, attraverso l’esistenza del simbolo, del discorso e della legge” (ivi).
Come abbiamo già accennato, a seconda del modo più o meno soddisfacente con cui il messaggio si realizza, possono qui fondarsi un certo numero di identificazioni perverse.
Secondo Tempo
Rivolgersi alla madre significa produrre una domanda, il soggetto interroga l’Altro e così facendo incontra, dice Lacan: “l’Altro dell’Altro e cioè la sua propria legge. E’ a questo livello che si produce che quanto ritorna al bambino è puramente e semplicemente la legge del padre, in quanto essa è immaginariamente concepita dal soggetto come quella che priva la madre” (p.195).
Se la madre può esserci oppure non esserci e questo disegna un al di là della madre, disegna anche un al di là del bambino, ciò significa che ella è mancante di qualcosa, ella desidera un oggetto che non necessariamente è il bambino, ovvero che il suo desiderio non si richiude su di lui.
Cito: “ciò che stacca il soggetto dalla sua identificazione lo riattacca nello stesso tempo alla prima apparizione della legge sotto la forma di questo fatto – che la madre è dipendente da un oggetto che non è più semplicemente l’oggetto del suo desiderio, ma è un oggetto che l’Altro ha oppure non ha” (ivi).
Il punto è dunque potersi staccare da questa prima identificazione, non coincidervi totalmente (psicosi – perversione), e cos’è che consente questo?
La legge, il fatto che l’Altro abbia una legge, cioè che ci sia un Altro dell’Altro e a questo livello possiamo vedere quanto l’Altro dell’Altro sia indispensabile, anche se poi Lacan affermerà che non c’è Altro dell’Altro, questo non significa che questa dimensione possa non essere operante, altrimenti avremmo la psicosi.
Cito: “sul piano immaginario, il padre interviene davvero come privatore della madre. Questo vuol dire che la domanda indirizzata all’Altro, se viene ritrasmessa come conviene, è rinviata ad una corte superiore, se posso esprimermi così” (p.194- 195).
Un eco di tutto questo, nell’aneddotica clinica, lo si intravede nel noto, frequente rimando della madre: “lo dico a papà!”, richiamo minaccioso, ma strutturante.
Si vede come il processo si sdoppi ad un livello secondo e questo impedisca la completa coincidenza tra bambino e madre. Ma perchè questo sia possibile ci vuole che sia costituito l’oggetto del desiderio della madre come una mancanza, il che dà luogo ad un fallo che deve essere sostenuto dalla legge paterna.
Ciò che conta dunque è, cito: “il rinvio della madre ad una legge che non è la sua ma quella di un Altro, con il fatto che l’oggetto del suo desiderio è sovranamente posseduto nella realtà da questo stesso Altro alla cui legge ella rinvia..” (p.195).
Il fatto che l’oggetto del suo desiderio non sia nelle mani della madre stessa ma sia posseduto dall’Altro, questo è al cuore della legge e questa è la chiave dell’Edipo, tuttavia, quello che dobbiamo tener ben presente è che ad essere in gioco non è la relazione con il padre ma la relazione con la parola del padre.
A questo proposito rientra in scena il piccolo Hans, suo padre non è di certo un imbecille, dice Lacan, anzi è uno spirito illuminato, presente, gentile, intelligente, amichevole, ha portato il figlio da Freud, eppure è, cito: “totalmente inoperante” (ivi).
Inoperante rispetto a cosa? Alla parola della madre, è inoperante, come legge, nella parola della madre, ella mantiene infatti una posizione ambigua rispetto al figlio: lo interdice dicendogli ad esempio: “non ti servire di quello, è disgustoso!” però lo ammette nella propria intimità e gli consente di tenere la funzione di oggetto immaginario, incoraggiandolo anche un pò. Così Hans, trovandosi ad incarnare il fallo della madre si trova, dice Lacan: “mantenuto nella posizione di assoggetto. Egli è assoggettato, e questo fatto è la sorgente della sua angoscia e della sua fobia. C’è un problema nella misura in cui la posizione del padre è messa in questione dal fatto che non è la sua parola che fa legge per la madre” (ivi).
Cioè non è un “terzo” a fare la legge.
Nel caso di Hans non è in questione la psicosi, ma la fobia, non c’è dunque forclusione, vuol dire che il nome del padre è operante ma non funziona del tutto bene? Non sarebbe sufficientemente potente? E’ un punto da discutere. Lacan parla di “gradi” come si trattasse di una clinica continuista, invece, in quest’epoca della teorizzazione lacaniana siamo abituati ad una clinica discontinuista dato il salto radicale tra nevrosi e psicosi che Lacan traccia proprio grazie alla teorizzazione del Nome del padre.
Ciò che viene a mancare nel piccolo Hans è ciò che dovrebbe prodursi nel terzo tempo dell’Edipo. La sua uscita dal complesso è falsata, dice Lacan, Hans ne viene fuori grazie alla fobia ma la sua vita amorosa resterà segnata da quello stile immaginario che vediamo anche nel caso di Leonardo da Vinci.
Terzo tempo
Siamo allora alla terza tappa che è quella dell’uscita, quella in cui dall’essere si passa all’avere, se così possiamo dire.
Se il padre rappresenta un “al di là” della madre ed incarna colui che il fallo non lo è ma ce l’ha, tantovero che può darlo, ciò significa che, in quanto portatore del fallo, egli funziona come supporter della legge perchè, a questo punto, è da lui che viene a dipendere il possesso o meno del fallo da parte del soggetto materno.
In altri termini il fallo non è un possesso della madre, la madre ha una mancanza e per questo viene a dipendere da un terzo che può darle, o meno, ciò
che desidera. Però il padre deve dar prova di averlo il fallo.
Il terzo tempo è quello, cito: “in cui può prodursi quell’oscillazione che reinstaura l’istanza del fallo come oggetto desiderato dalla madre e non più soltanto come quell’oggetto di cui il padre possa privare” (ivi).
Ecco il punto chiasmatico che lega l’oggetto del desiderio alla legge, in omaggio a San Paolo… Non c’è desiderio senza mancanza.
Sul piano logico, non cronologico perchè va pensato come simultaneo, il padre della seconda fase, quello che priva, è il padre onnipotente. Tuttavia nell’interpretazione psicoanalitica, i due momenti: quello del desiderio e quello della privazione sono stati disgiunti, tanto che le analisi del complesso di Edipo si arrestavano a questo stadio perchè si pensava che le devastazioni del complesso derivassero dall’onnipotenza paterna senza comprendere che la castrazione in gioco nel complesso è la privazione della madre e non quella del bambino.
L’attenzione andava al bambino privato di qualcosa e questo è una delle componenti del complesso, ma ad essere in gioco è, precipuamente, la privazione della madre, ed è questo che dà all’oggetto il suo posto e dunque dà al soggetto la possibilità di staccarsi.
Lacan lo dice sotto la forma del dono, il dono da parte di un terzo, cito: “il padre può dare alla madre ciò che ella desidera, e può darglielo perchè ce l’ha. Qui interviene dunque il fatto della potenza nel senso genitale del termine – diciamo che il padre è un padre potente. Per questo la relazione della madre con il padre ripassa sul piano reale” (ivi).
Si ripassa dunque al padre reale, tuttavia questo tempo terzo in cui il padre interviene come reale e potente è possibile solo dopo la privazione e la castrazione che concerne la madre, la madre di un soggetto che si trova nella posizione immaginaria di dipendenza. Cito: “In quanto il padre interviene come colui che ce l’ha, viene interiorizzato nel soggetto come Ideale dell’Io e da quel momento il complesso di Edipo declina” (ivi).
L’uscita dall’Edipo è consentita dunque da un’ identificazione speciale che Freud ha chiamato Ideale dell’Io. Nel triangolo simbolico ai cui vertici compaiono Padre, Madre e Bambino, l’Ideale si colloca nel polo del bambino nella misura in cui, dice Lacan: “è nel polo materno che comincia a costituirsi tutto ciò che in seguito sarà realtà, mentre è a livello del padre che comincia a costituirsi tutto ciò che sarà in seguito Super Io” (ivi).
Riassumendo è dunque in tre tempi che si compie l’identificazione con l’istanza paterna. Cito: “nel primo tempo l’istanza paterna si introduce in forma velata, il padre già esiste perchè nel mondo regna la legge del simbolo e per questo la questione del fallo è già posta da qualche parte nella madre dove il bambino deve reperirla” (p.196). Nel secondo tempo il padre si afferma come presenza privatrice facendo la sua comparsa in modo mediato dalla madre che
lo pone come colui che fa la legge. Infine, nel terzo tempo il padre si rivela come colui che ce l’ha, ponendosi così come Ideale e ciò consente al soggetto l’uscita dal complesso.
Ciò non significa però che il bambino, uscendo dall’Edipo, si trovi in possesso dei suoi poteri sessuali e possa esercitarli, anzi quelle funzioni che si erano svegliate sembrano decadere, è per questo che questa fase è stata chiamata di “latenza”, in riferimento all’assopirsi della pulsione che non significa però la sua scomparsa. A questo si deve il fatto che Lacan dichiari che il bambino ha in tasca i titoli che gli serviranno in futuro.
E’ proprio in questo che vediamo all’opera la metafora paterna, cioè vediamo che la funzione paterna è quella metaforica, cito: “si istituisce qualcosa dell’ordine del significante, che è là in riserva e la cui significazione si svilupperà più tardi” (ivi).
l bambino acquisisce così il diritto di essere un uomo e se, a questo proposito, qualcosa nella pubertà farà da ostacolo, ciò sarà da rapportare al non completo compiersi dell’identificazione metaforica con l’immagine del padre così come si è costituita nei tre tempi descritti.
A questo punto Lacan afferma con umorismo: “Nella misura in cui è virile l’uomo è sempre, più o meno, la propria metafora. Questo mette sul termine di virilità un ombra di ridicolo di cui bisogna in ogni modo tenerS conto..” (p.198).
Come dargli torto! E per la donna?
Si sa che la sua uscita dall’Edipo è diversa da quella del maschio, se leggiamo Freud nel suo lavoro: “Declino del complesso edipico” questa terza tappa risulta più semplice. Afferma Lacan: “ella non deve infatti compiere questa identificazione, nè mantenere questo titolo rispetto alla virilità. Lei sa dov’è e dove andare a prenderlo, è dal lato del padre e va verso colui che ce l’ha” (ivi).
E qui Lacan ci lascia con una suggestione: “c’è sempre una dimensione di alibi.. un che di smarrito nelle vere donne“(ivi).
Con questo rilancio la questione rimane aperta, la “semplicità” della situazione dal lato femminile è infatti, solo apparente. Come si identifica la donna? Di certo anche lei deve costituire un ideale. Come esce dal legame col padre se può tranquillamente rimanere ancorata a questo secondo oggetto? Rimando per questo alla trattazione che le colleghe stanno facendo, per esempio a proposito della psicosi “al femminile” o a proposito del ravage come devastazione tra madre e figlia…
Nel prossimo capitolo, dice Lacan: “ritorneremo su ognuna di queste tappe per vedere cosa vi si applica” (ivi) e nel concludere questo capitolo torna a giustificare il termine di metafora.
Se nessuno ha mai potuto “spillare” (punto di capitone) una significazione ad un significante, egli ci dice, si può invece spillare un significante ad un altro
significante, ne verrà fuori qualcosa di nuovo, di inatteso, una nuova significazione.
Cito: “Il padre è, nell’Altro, il luogo che rappresenta l’esistenza del luogo della catena significante come legge. Egli si pone, se così posso dire, al di sopra di essa” (ivi). Ma il padre può essere in una posizione metaforica solo se la madre fa di lui colui che sanziona, con la sua presenza, l’esistenza del luogo della legge. Il modo in cui questo può realizzarsi ha un’immensa estensione nelle vite individuali.
Il terzo tempo del complesso di Edipo può essere superato dal ragazzino con l’identificazione al padre in quanto possessore di pene, e dalla fanciulla con il riconoscere l’uomo come colui che lo possiede.
Il resto al prossimo capitolo, ancora dedicato ai tre tempi dell’Edipo.


