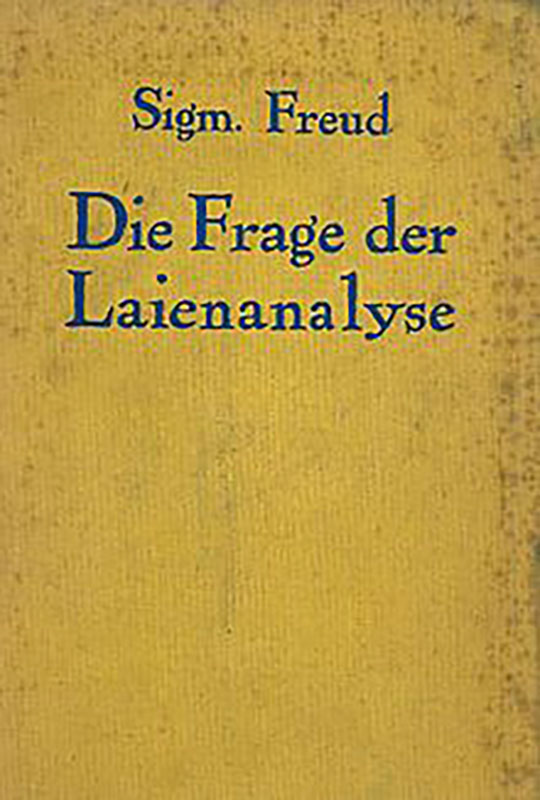
14 Mar La questione dell’Analisi laica
“Il Problema dell’Analisi condotta dai Non-Medici”
Il dibattito aperto da Freud sulla discrepanza tra psicoterapia e psicanalisi, l’incompatibilità delle due, è più che mai attuale. Il fatto che è una questione ampia rispetto alla stessa esistenza della psicanalisi emerge soprattutto dallo scritto di Freud sulla LAIENANALYSE, in cui Freud non solo difende il cosiddetto analista laico, ma vuole proteggere la psicanalisi dalla medicina.
Freud non smetterà mai, finche vivrà, e questo sono le sue stesse parole, di lottare contro la fagocitazione della psicanalisi da parte della medicina, perché, infatti, in tal caso, cioè se ciò succedesse, ogni cura analitica diverrebbe psicoterapia. Il termine stesso di terapia non è forse squisitamente medico? Un tempo, qui in Italia, si sentiva spesso dire che i medici mandano dei pazienti da un’analista, o meglio da un terapeuta con la richiesta: per analisi e eventualmente successiva terapia.
Sapevano che terapia, la parola terapia, deriva etimologicamente da TARNEN – mimetizzare? Sentite l’impatto ….
Quando Freud scriveva la LAIENANALYSE nel 1926, vedeva la psicanalisi pero minacciata anche da altre cose: Come pericolo Freud cita la religione (e oggi??), ad esempio. Ma che questa minaccia alla psicanalisi da parte della medicina e della religione abbia un significato più ampio è qualcosa che vorrei illustrare di seguito. Seguo il consiglio di (in Lacan quando scrive (in Ornicar 9): “… la clinica psicanalitica consiste nel rimettere in discussione tutto ciò che Freud ha detto”, e quindi non esiterò a citare molto nella mia letteratura di Freud con Lacan.
Nello stesso anno degli addenda all’Analisi Laica, 1927, Freud scrive “L’avvenire di un’illusione”. Qui contrappone la psicanalisi alla religione, illusione per eccellenza, dalla quale deve essere protetta.
E oggi, cosa ha sostituito le religioni ossia cosa ha carattere di religione nella sua sicurezza assoluta, che cosa si fa per raggiungere una vita eterna?
Freud si chiede quale futuro può avere questa illusione. (mi chiedo in cosa si è trasformata oggi – l’illusione – se mai …) Freud precisa che si tratta di un’illusione e non di un errore, perché la religione, proprio come un delirio, si basa su un desiderio fantasmaticamente soddisfatto: sull’idea di un unico Dio, Padre onnipotente, che con il suo amore protegge gli esseri umani, i suoi figli, nella loro HILFLOSIGKEIT, il loro essere senza aiuto alcuno, la loro derelizione contro ogni potenza naturale. Gli uomini credono in questo Dio Padre e alimentano così il loro narcisismo pensandosi esserne i figli eletti.
Freud affronta la connessione tra “analisi laica” e illusione nella sua corrispondenza con Oscar Pfister (pastore protestante, psicanalista svizzera, la loro corrispondenza va dal 1909 – 39).
Nella lettera del 25.11.1928 si legge:
“Non so se ha intuito il legame segreto tra (gli scritti su) l’analisi laica e l’illusione, nella prima voglio proteggere l’analisi dai medici, nell’altra dai preti. Vorrei consegnarla a un ceto che ancora non esiste, un ceto STAND VON WELTLICHEN SEELSORGERN di curatori pastorali civili, pastori laici, che non hanno bisogno di essere medici e non devono essere preti”.
Naturalmente ci si può offendere per il termine ‘pastore’, lo conosciamo per il sacerdote o il pastore che si prende cura delle anime del gregge della sua congregazione. Ma nella LAIENANALYSE Freud si inventa questo termine.
Lo psicanalista è colui, che da laico si prende cura dell’anima, della psiche, partendo per l’appunto dallo psichico, e quindi cercando un cambiamento che viene dall’interno. Non è colui che ‘sostiene i difetti dall’esterno’, sarebbe psicoterapia, dice Freud, e soprattutto non è colui che ascolta la confessione! Perché – cito Freud – “noi, analisti, non solo vogliamo sentire da lui, il paziente, ciò che sa e nasconde agli altri, ma dovrebbe anche dirci ciò che non sa.”
Non stiamo forse leggendo proprio una definizione – una descrizione – dell’inconscio come un sapere che non si sa, che non si sa di sapere? Se il peccatore dice quello che sa, il nevrotico dica di più, aggiunge Freud. E ricorda a Pfister che l’analista non può dire: “i tuoi peccati ti sono perdonati, alzati e cammina” come fa e può farlo Cristo, perché è il Figlio di Dio e solo per questo realizza “un transfert senza limiti e basato su un effetto di suggestione.”
L’analista, invece, analizza l’origine e la giustificazione del transfert. Non si accontenta di un successo di suggestione – ammesso che riesca di produrlo.
L’analista, dovrebbe essere profano, nel senso che è al di fuori di ogni sacralizzazione del sapere e del potere.
E cosi leggerei l’ammonimento di Freud che la psicanalisi dovrebbe essere protetta dalla medicina, cosi come dalla religione. Entrambi, sia la medicina che la religione si occupano del buono, anzi della bontà e del bene WOHL dell’uomo; sanno quindi cosa è il suo bene e il buono, trovandosi cosi dalla parte del potere: il potere di fare il bene. Lacan scrive in “La direzione della cura” “nessun potere ha altro fine – che fare il bene – e quindi il potere non ha fine”.
La psicanalisi, invece, è il luogo del riconoscimento del desiderio, desiderio inconscio, che non è WUNSCH di alcun bene o del buono. È l’esatto contrario di quel bene e di quel benessere, è ciò che ci dilania e ci tormenta, il meglio e peggio in noi, di noi.
Pertanto la psicanalisi si distingue per una etica. etica del desiderio. Senza rigore etico, scrive Lacan, ogni cura psicanalitica non è che psicoterapia.
Freud parla di una banale terapia delle nevrosi, e teme che la psicanalisi diventi proprio questo, con un dominio della medicina, mentre per lui l’efficacia della psicanalisi sta proprio nel fatto che è uno strumento imparziale di ricerca, una scienza, WISSENSCHAFT in tedesco, cioè letteralmente qualcosa che crea sapere.
Ma leggiamo alcuni passaggi importanti in cui Freud esprime i suoi timori.
La LAIENANALYSE.
“Infatti, non intendiamo auspicabile che la psicanalisi venga assorbita VERSCHLUCKT, inghiottita dalla medicina, per poi trovare il suo deposito definitivo nel manuale di psichiatria, nel capitolo dedicato alla terapia, accanto a metodi come la suggestione ipnotica, l’autosuggestione, la persuasione che, tratti dalla nostra ignoranza, ringraziano l’inerzia e la vigliaccheria delle masse umana per i loro effetti di breve durata. Essa merita un destino migliore.”
Freud affianca sempre il termine terapia a quello di suggestione; ad esempio in “Consigli al medico nel trattamento psicanalitico” scrive:
“Tuttavia non c’è praticamente niente da dire contro uno psicoterapeuta che mescola un pezzo di analisi con una parte di influenza suggestiva per ottenere un successo visibile in un tempo più breve, come diventa necessario, per esempio, nei manicomi, ma si può esigere che egli stesso non abbia dubbi su ciò che sta facendo e che sappia che il suo metodo non è quello della psicanalisi vera e propria.”
E poi, in “Sull’avviamento EINFÜHRUNG del trattamento”:
“Il transfert può spesso eliminare i sintomi della sofferenza (io: noi forse diremmo la sofferenza del sintomo, vedremo) ma solo temporaneamente, fintanto dura esso stesso. Si tratta quindi di un trattamento suggestivo, non di una psicoanalisi. Il trattamento merita quest’ultimo nome solo quando il transfert ha usato la sua intensità per superare le resistenze. Solo allora essere malati è diventato impossibile, anche se il transfert è stato di nuovo sciolto, liquidato, come richiede il suo destino BESTIMMUNG.”
O ancora in “Vie della terapia analitica”, scritto sotto l’influenza della Prima guerra mondiale, nel 1918/19, quando Freud pensava di poter fondare un Policlinico psicoanalitico, cui tecniche dovevano essere adattate alla situazione allora attuale, un’istituzione pubblica con cure gratuite per i poveri del popolo:
“Probabilmente saremo anche costretti nell’applicazione di massa della nostra terapia a legare abbondantemente l’oro puro dell’analisi con il rame della suggestione diretta, e l’influenza ipnotica potrebbe trovare nuovamente posto, come nel trattamento dei nevrotici di guerra. Ma qualunque sia la forma di questa psicoterapia per il popolo, qualunque siano gli elementi che la compongono, i suoi costituenti più efficaci ed importanti rimarranno certamente quelli attinti dalla psicoanalisi rigorosa e senza tendenze.”
Riassumiamo le parole di Freud:
La psicoterapia può essere condotta in istituzione con gli psicotici, ma solo a condizione che l’analista sappia cosa sta facendo. Può essere effettuata gratuitamente in un’istituzione, ma si scoprirà presto che in questo modo ha poco valore: il paziente preferisce mantenere i suoi sintomi, piuttosto che affrontare il suo “povero mondo” senza il guadagno collaterale della nevrosi.
Inoltre, ciò che distingue la psicoanalisi per eccellenza dalla terapia è l’uso del transfert e dell’amore del transfert. Entrambi vengono utilizzati per il lavoro nell’analisi cioè l’analisi del transfer, e non per la repressione dei sintomi. Quest’ultimo significherebbe proprio coprire ciò che non va, che non funziona, anziché analizzarlo.
Ma ciò di cui Freud non smetterà mai di mettere in guardia è l’ambizione dell’analista, del desiderio di guarire, dal FUROR SANADI, che Freud chiama addirittura un affetto pericoloso. Infatti espone l’analista alla situazione di provocare la resistenza del paziente (che non vuole guarire). Se questo non è piuttosto la resistenza dell’analista? Ricordate la frase di Lacan: la resistenza in analisi è la resistenza dell’analista.
Sebbene Freud parli del “desiderio di guarigione – WUNSCH – del paziente, aggiunge subito che è proprio ciò che il paziente non vuole, guarire, sia perché questo lo priverebbe del guadagno secondario della nevrosi, sia perché andrebbe contro il suo complesso di colpa e contro qualcosa che Freud chiama TODESTRIEB, pulsione di morte, ciò che imperversa in noi come distruttivo e non si placa, persiste ancora e ancora – coazione di ripetere WIEDERHOLUNGSZWANG.
Freud arriverà poi a mettere la parola guarire tra virgolette quando si chiede in che misura e in che modo il nevrotico possa guarire.
Al posto del HEILUNGSWUNSCH, dietro il quale può nascondersi proprio il desiderio di non guarire, di non star meglio, parla nel “Compendio” di un bisogno di GENESUNG – riprendersi, rimettersi, ristabilirsi, insomma rinascere – che, insieme ad un interesse intellettuale e al transfert può aiutare il paziente, motivato dalla sua sofferenza, nel lavoro analitico. In altre parole, l’analisi può avere un impatto, un effetto legato all’interesse intellettuale, come scrive Freud in “Analisi Laica”.
“Il riconoscimento ERKENNUNG portava al successo, non si poteva curare, senza imparare qualcosa di nuovo, non si otteneva l’illuminazione senza sperimentarne l’effetto benefico.” Insomma, la “guarigione” viene in surplus.
La conoscenza o piuttosto il riconoscimento del desiderio nella parola? Dire no al desiderio, significa anche riconoscerlo come parlato, come desiderio, e questo ha sempre un valore di acquietamento, di riconciliazione.
Tutt’altra cosa che guarire, non vi sembra? Nel guarire si tratterebbe del rendere sano, intatto, intero.
La psicanalisi, invece, non ripara, non sana, non colma nessuna mancanza, non risana la scissione, scissione originaria dell’Io, del soggetto che è scisso perché parla e perché ciò parla in lui, e che è soggetto a un desiderio che significa mancanza. E poi, da che cosa dovrebbe essere guarito l’uomo che, come dice Lacan, in quanto “parletre” parlessere è un animale malato della parola.
Alla fine, nel Compendio, (ABRISS) Freud ha trovato cosa può succedere all’uomo in analisi, egli può GENESEN, può recuperare. L’avete sentito, a differenza di HEILEN, GENESEN è un verbo intransitivo – dunque nessun altro può recuperare un altro. La sua radice riconduce a “uscirne vivi”. Un secondo significato è: essere slegato, liberato da, ENTBUNDEN WERDEN, che è l’espressione tedesca per il far nascere nel parto. Effettivamente il neonato viene slegato dal corpo materno – o è forse l’inverso?
E in effetti, il lavoro analitico può portare ad un uscirne vivi LEBEND DAVON KOMMEN, del desiderio, ad un parto, cioè una nascita del soggetto.
Nell’analisi si tratta anche di un liberarsi, slegarsi dalla dipendenza – spesso fatale – del desiderio della madre, del nascere al riconoscimento del proprio desiderio come desiderio dell’Altro.
Vorrei tornare ora sulla questione della religione, che promette pure un HEIL una salvezza, – il salvatore in tedesco è HEILAND. La salvezza della religione, però, è promessa per l’al di là, con cui anche la morte non è più distruzione e perde il suo nonsenso UNSINNIGKEIT. L’illusione della religione da un senso a tutto, persino alla NOT DES LEBENS, come lo chiama Freud, alla ANANKE della vita.
Proprio a Roma Lacan parlò, in una conferenza stampa nel 1974, della questione di chi avrebbe vinto, la psicanalisi o la religione. o l’una o l’altra, non c’è altra possibilità, secondo lui. Già allora non sembrava molto ottimista, “elles vont gagner”, vinceranno, avrebbe detto durante una passeggiata nella Citta Eterna, indicando le innumerevoli cupole delle chiese. E nella conferenza Lacan specifica: “La religione, quella vera, romana, è fatta per guarire gli uomini, di modo che non si rendano conto di ciò che non va. … La psicanalisi, invece, si occupa proprio di ciò che non va, CE QUI CLOCHE e questo è il Reale.”
Sì, la psicanalisi è scomoda e scandalosa; non parla di un’armonia perduta che va solo ritrovata, non risponde alla HILFLOSIGKEIT, nostra impotenza originaria, con l’illusione di un padre onnipotente che ci protegge e dà senso alla morte così come alla vita; non mette un’illusione al servizio del nostro narcisismo.
E Freud dice che è la bisogna della vita NOT – ANANKE – che ci spinge verso la religione o verso la psicanalisi.
Nel suo scritto “L’Avvenire di un Illusione”, Freud contrappone l’ananke al logos, (preso dal MULTATULI pseudonimo dello scrittore olandese Dekker) e afferma:
“L’unica speranza di uscire dal nostro comportamento infantile nei confronti della bisogna NOT della vita, dell’ananke, risiede nel logos della ragione.”
Oltre al logos – ragione ma soprattutto parola – Freud ha fiducia nell’intelletto – entrambi, logos come intelletto, hanno d’altronde la stessa radice etimologica, ovvero leggere.
Sentiamo ancora Freud:
“… la voce dell’intelletto è bassa, ma non si riposa fin quando non si è procurato ascolto. Alla fine, dopo innumerevoli e ripetuti rifiuti lo trova”
E come non sentire, leggere qui l’insistenza del significante inconscio del desiderio che né si ferma né si sottrae a nulla.
Freud ha fiducia nel fatto che l’intelletto abbia il sopravvento proprio perché il suo potere deriva dal logos, di cui peraltro dice:
“Il nostro Dio logos realizzerà di questi desideri WUNSCH ciò che la natura permette a prescindere da noi” – per concludere con – “No, la nostra scienza non è un’illusione. Un’illusione, invece, sarebbe credere di poter ottenere altrove ciò che essa non può darci.”
Per dirlo con Lacan : « … l’analyse ne change rien au réel, et … elle change ‘tout’ pour le sujet… (parce que) …l’analyste fait d’une fonction qui est commune à tous les hommes un usage qui n’est pas à la portée de tout le monde, quand il porte la parole. »¯
«L’analisi non cambia nulla del reale … e cambia tutto per il soggetto … (perché) … l’analisi fa di una funzione comune a tutti gli uomini un uso che non è alla portata di tutti, quando porta la parola.”
Johanna Vennemann


