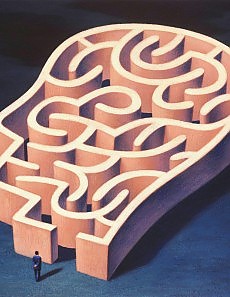
30 Mar L’emergere dell’arcaico nella cura analitica: la posizione dell’analista – di Elisabeth Du Boucher-Lasry
“Abbiamo dunque motivo di supporre l’esistenza di una rimozione originaria, e cioè di una prima fase della rimozione che consiste nel fatto che al rappresentante psichico ( rappresentante, Repräsentanz / rappresentazione, Vorstellung) di una pulsione, viene interdetto l’accesso alla coscienza. Con ciò si produce la fissazione: il rappresentante psichico (Repräsentanz) in questione continua da allora in poi a sussistere immutato, e la pulsione rimane ad esso legata”.
di Elisabeth Du Boucher-Lasry
Introduzione
Prima di parlarvi dell’emersione dell’arcaico nella cura analitica e della posizione dell’analista, riassumerò alcuni elementi teorici per contestualizzare quello che dirò in seguito sulla posizione dell’analista.
Naturalmente, esplorare questi periodi arcaici dello sviluppo del soggetto non è cosa facile.
Tuttavia troviamo dei riferimenti già nello stesso Freud. In Ferenczi ritroviamo molti chiarimenti e numerose indicazioni che anticipano, più di quanto si pensi, quanto dice Melanie Klein prima e Winnicott in seguito. Lacan fornisce dei punti di riferimento ben precisi sulla costruzione della relazioni d’oggetto in particolare nella fase in cui il soggetto accede al simbolico.
Sebbene complessi o parziali, e provenienti da corpus teorici e da autori piuttosto distanti gli uni dagli altri, questi chiarimenti sono più coerenti e complementari tra loro di quanto si potrebbe credere.
Freud ha contestualizzato la questione che ci interessa.
Nel 1915, in Metapsicologia, Freud scrive:
“Abbiamo dunque motivo di supporre l’esistenza di una rimozione originaria, e cioè di una prima fase della rimozione che consiste nel fatto che al rappresentante psichico ( rappresentante, Repräsentanz / rappresentazione, Vorstellung) di una pulsione, viene interdetto l’accesso alla coscienza. Con ciò si produce la fissazione: il rappresentante psichico (Repräsentanz) in questione continua da allora in poi a sussistere immutato, e la pulsione rimane ad esso legata”.
Freud usa indifferentemente le parole Repräsentanz e Vorstellung. Tuttavia Richard Abibon avanza la possibilità di tradurre le due parole in due modi diversi. Abibon propone di tradurre Repräsentanz con ‘iscrizione’ e Vorstellung con ‘scrittura’. Questa differenza potrebbe infatti evocare la differenza che Freud faceva tra:
– il rappresentante della pulsione rimossa originariamente, che si colloca piuttosto nel registro dell’iscrizione
– il rappresentante della pulsione rimossa secondariamente, che si colloca pittosto nel registro della scrittura.
In ogni caso, questa distinzione tra iscrizione e scrittura evoca ciò che Freud dice a proposito di questi due tipi di rimosso: il primo è illeggibile, sebbene inciso nella memoria, mentre il secondo è leggibile mediante la decodifica dell’interpretazione.
Vedremo che, almeno per il soggetto, il carattere illeggibile delle iscrizioni arcaiche, è un elemento essenziale durante lo svolgimento della cura.
Nel 1913, Freud aveva già scoperto che le angosce del paziente connesse alla situazione edipica (castrazione, perdita di una parte del corpo, di un oggetto o perdita di autostima), corrispondevano all’apparire, durante l’analisi, di una nevrosi da transfert, che poteva essere guarita con la terapia. Quando però le angosce riguardavano invece l’esistenza stessa, la sopravvivenza, l’identità (nevrosi narcisistiche e psicosi), da una parte la nevrosi da transfert non si manifestava e dall’altra, la psicoanalisi, nella sua forma classica, non produceva effetti.
In altre parole, sin dal 1913, Freud aveva identificato questo limite del trattamento psicoanalitico, nella sua forma più classica, costituita dall’arcaico.
Ho deciso di chiamare “arcaico”, almeno nell’ambito di questa esposizione, ciò che si riferisce al periodo durante il quale si manifesta la rimozione originaria. Vale a dire ciò che si costituisce nella psiche del soggetto già prima della formazione dell’inconscio e dell’Io in senso freudiano, ciò che esiste nella psiche durante i suoi primi mesi di vita e, in qualche misura, durante la vita fetale.
Nel tentativo di identificare l’arcaico nella costituzione della psiche, proviamo a pensare alla cronologia dei primi giorni di vita dopo la nascita, dopo la vita fetale, per cercare di proporre una versione dei fatti che emergono alla luce dell’esperienza analitica, versione che, ovviamente, sarà parziale.
In primo luogo vi è il periodo di dipendenza assoluta neonatale: dalla nascita fino ai 3 mesi circa.
Il bambino appena uscito dal ventre materno si trova confrontato a una esperienza fondamentale, fatta allo stesso tempo di sconforto, di totale “desolazione” ( la”Hilflosigkeit” di Freud) fisiologica e psicologica, legata agli effetti di mancanze reali. Nell’utero, il feto aveva trovato un soddisfacimento quasi perfetto e totale delle sue esigenze di sviluppo: il freddo e la fame, ad esempio, gli erano stati fino a quel momento completamente estranei. Per quanto, anche la vita fetale sia resa varia in più modi: se la madre mangia dello zucchero, il feto manifesta entusiasmo e soddisfazione. Tracce di eventuali stress materni possono presto ritrovarsi nel comportamento del feto il quale, come gli adulti, può soffrire di tachicardia quando vi è motivo di preoccupazione.
Ritorniamo al neonato. E’ in una posizione di dipendenza assoluta. L’Altro-materno-originario garantisce la soddisfazione dei suoi bisogni primari, cibo, cura del corpo, e, assicurando l’holding, il sostegno del bambino, tanto quello fisico quanto e soprattutto quello psichico.
Durante questo periodo iniziale, l’Altro-materno-originario svolge funzione di “Io ausiliario”: fermo restando che l’espressione “Io arcaico ” debba intendersi qui, naturalmente, senza alcun riferimento all’ “Io” dell’adulto. In questa fase, il bambino non può ancora distinguere l’Io dal “non-Io”. Prima della fase dello specchio, non c’è che un solo corpo per due.
L’ Altro-materno-originario di cui parliamo e dal quale il neonato è assolutamente dipendente, è la figura principale di quello che Winnicott chiama “ l’ambiente facilitante”.
Sebbene il soggetto sia inscritto nel linguaggio già da prima del suo concepimento, in quella fase il bambino può esprimersi solamente con il suo corpo, non avendo ancora le parole per farlo.
Dopo il primo grido di soffocamento del momento della nascita, le grida del neonato esprimeranno da un lato il suo sconforto, dall’altro la necessità di soddisfare i propri bisogni.
Questo richiamo all’altro richiede risposte appropriate, e strettamente vitali.
La disperazione primordiale (l’impotenza originaria?) è una prima esperienza fondamentale, un punto di organizzazione e struttura che sarà vittima dell’oblio e che diventerà oggetto della rimozione originaria, ma che, in quanto tale, potrà ritornare sotto forma di tracce e costruzioni nel soggetto adulto ed emergere durante la cura analitica. Ad esempio quando il soggetto si troverà confrontato ad esperienze che riattivano in lui lo stato originario di sconforto: il lutto, una malattia grave, una guerra, ecc.
Questo stato di sconforto del neonato, può essere superato se la presenza dell’Altro-materno è efficace e benevola, condizione che permetterà allora al bambino degli incontro positivi.
Secondo Winnicott, durante le prime fasi di sviluppo affettivo nei bambini, i disagi esistenziali sono una parte necessaria del processo di sviluppo, anche in assenza di patologia.
Questi disagi esistenziali, queste angosce, accompagnano l’inizio della vita e i vari periodi di strutturazione del soggetto, ogni fase del suo sviluppo, ripresentandosi ogni qualvolta accede ad una nuova funzione simbolica.
È solo superandoli, grazie ad un ambiente facilitante e sufficientemente buono, che i neonati e i bambini piccoli passano alla fase successiva del loro sviluppo.
Tuttavia, ogni tappa decisiva dello sviluppo del soggetto, è segnata, in parte, da insuccessi, che possono essere causa di dolore e la cui intensità colpirà il soggetto con conseguenze a carattere permanente o ricorrente.
Ad ogni tappa, se le difficoltà sono troppo grandi o in mancanza dell’Altro benevolo, possono verificarsi delle angosce originarie di spezzettamento o “agonie primitive”. Fermiamoci un istante sulla scelta delle parole. La difficoltà consiste nel tradurre il termine inglese “agony” usato da Winnicott. Winnicott afferma la necessità di trovare una parola che abbia un significato molto più forte di quello di ‘angoscia’ che è del tutto insufficiente per registrare quello che possono provare, in alcuni casi, alcuni bambini, – non tutti per fortuna.
Quindi, se le difficoltà sono troppo grandi, le strategie difensive attuate dal soggetto, che sul momento, sembrano efficaci, possono invece spianare la strada per i disagi psichici futuri.
Winnicott ci fornisce una serie di esempi di queste diverse “agonie primitive” che alcuni neonati possono vivere in certi casi. Ecco alcuni esempi:
1) Ritorno ad una fase di non-integrazione
2) La paura del crollo
3) fallimento del sentimento di appartenenza somatica
4) Perdita del senso della realtà
5) Perdita della capacità di essere in relazione con gli oggetti
Ciascuno di questi esempi di angosce primitive di spezzettamento, meriterebbe un lungo commento, se non altro per spiegare meglio ciò che annota Winnicott.
Ci aiuterebbe inoltre a capire meglio la difesa specifica che il soggetto costruisce quando è confrontato ad una di queste agonie primitive.
In ogni caso, nell’elaborare le sue strategie di difesa, il soggetto ripiega sui sostegni psichici interni. Queste strategie di difesa, anche se momentaneamente vincenti, sono in realtà ciò che si manifesterà più tardi nel soggetto adulto, espressioni delle mancate soluzioni connesse alla rimozione originaria.
In altre parole, ciò che in seguito, durante la terapia, si manifesterà prima di tutto, non sarà il trauma arcaico, ma bensì la difesa costruita dal soggetto durante il periodo arcaico.
Commenterò una di queste agonie, la perdita della capacità di essere in relazione con gli oggetti. Sarà l’occasione per analizzare la coerenza dei chiarimenti forniti da Lacan e Winnicott.
In questo caso, dice Winnicott, l’organizzazione difensiva si costruisce attraverso un rapporto esclusivo con gli “auto fenomeni”. Si tratta di una strategia di difesa che genererà per il soggetto degli stati autistici.
Ora, nel seminario IV, “la relazione d’oggetto”, Lacan ci spiega dettagliatamente il ruolo della frustrazione nella costruzione della relazione d’oggetto e nell’accesso al simbolico che ne risulta: è noto che certe carenze nell’ambito della frustrazione e dell’accesso al simbolico, siano all’origine dell’autismo.
Qui di seguito riprendo l’argomento in modo più dettagliato.
In Winnicott, nella prima fase dello sviluppo del bambino, si parla di “integrazione” dell’Io e di “installazione” dell’oggetto: Winnicott afferma che quando esce dalla fase di dipendenza assoluta, fase durante la quale non ha ancora la coscienza della sua dipendenza, il neonato entra nella fase della relazione d’oggetto, in cui prende “le misure” della propria dipendenza e della sua capacità di comunicare al suo ambiente che ha bisogno di lui.
Questa teoria è coerente rispetto a ciò che Lacan dice nel seminario IV, quando parla in dettaglio dei tempi logici della fase arcaica: il neonato costruisce, attraverso i tempi logici, la relazione d’oggetto e i tre registri del reale, dell’immaginario e del simbolico.
Vediamo insieme, rapidamente, come Lacan parla di questa fase della vita del neonato.
Lacan sostiene che per comprendere cosa sia in gioco in questo periodo arcaico, bisogna “partire dalla frustrazione, il vero snodo delle relazioni primitive del bambino”.
Ci sono due versanti nella frustrazione, dice Lacan.
Da una parte l’oggetto, la cui mancanza frustra il soggetto, dall’altra l’agente, la madre in questo caso.
L’oggetto, il seno, per esempio, è in un primo tempo reale, in quanto appare, in un primo tempo, attraverso le carenze-nella-periodicità.
Perché l’oggetto appaia in quanto oggetto, la temporalità legata alla permanenza è stata già superata; la periodicità si è sostituita alla permanenza, e non siamo più di fronte a una dipendenza assoluta. C’è un inizio minimalista di non-dipendenza, sufficiente perché le carenze siano tollerate dal soggetto.
Perché l’oggetto si presenti in quanto oggetto-attraverso-le-carenze, non importa, ci dice Lacan, che in questa fase primitiva non ci sia distinzione tra Io e non-Io.
Cito Lacan:” :”L’oggetto materno viene sollecitato quando si ritrova ad essere assente, e quando è presente viene rifiutato, sullo stesso registro del richiamo, tramite vocalizzazione”. A questa tappa della costituzione del soggetto, la madre, cioè l’agente, integra un elemento importante, la “presenza-assenza” scansionata dalla vocalizzazione, elemento che appare come fondatore, per il soggetto, di una prima possibilità di accesso all’ordine simbolico.
Così la madre è in un primo tempo, nel dispositivo della relazione primitiva, una madre simbolica: presente su un fondo di assenza e assente su fondo di presenza.
Ed è ora che subentra la frustrazione.
Quando il bambino capisce che la madre ha il potere di rispondere a suo piacimento, secondo la sua volontà, la madre diventa, per il bambino, una potenza, diventa reale. È a partire dal momento in cui l’accesso all’oggetto comincia a dipendere dalla volontà della madre, che l’oggetto diventa “oggetto di dono”. L’oggento diventa, cioè, simbolico.
Per il momento, il registro dell’immaginario manca, arriverà presto, ma per il momento non ve n’è traccia.
Soffermiamoci sul fatto che in questa fase dello sviluppo, l’onnipotenza non è dal lato del bambino ma da quello della madre, e che tale onnipotenza materna, provoca nel soggetto un effetto depressivo che sarà una tappa necessaria al suo sviluppo.Il soggetto dovrà ancora acquisire la facoltà di riflettere su se stesso e sulla sua impotenza, ed anche realizzare che il corpo della amdre, non è il suo. Ma siamo ancora lontani da questa fase del suo sviluppo.
Ecco quindi la madre e il bambino legati da un rapporto dialettico in cui il bambino si aspetta qualcosa dalla madre: aspetta un dono.
E, improvvisamente, può ricevere qualcosa dalla madre.
E questo qualcosa, per dirla in modo semplice, è l’idea che ricevendo doni dalla madre, il soggetto si creda amato da lei.
Dopo essere passato dalla permanenza dell’oggetto alle carenze nella periodicità e dopo aver in questo modo costruito la relazione all’oggetto reale, dopo aver scoperto il dono e la potenza materna e aver costruito la relazione all’oggetto simbolico, sono le “carenze e le frustrazioni che intaccano l’onnipotenza materna” che permetteranno al neonato di giungere alla fase seguente.
Lacan parla infatti dello sdoppiamento relativo al desiderio materno del fallo e alla superposizione da parte della madre dell’immagine fallica all’immagine del bambino.
Lacan dice che ciò che sarà decisivo, in questa fase, per lo sviluppo del soggetto, sarà la nozione di mancanza del fallo da parte della madre e come essa stessa si determini in quanto desiderante, segno manifesto di una carenza nella sua onnipotenza.
E’ la tappa in cui il bambino si trova coinvolto nella dialettica intersoggettiva dell’illusione. Per soddisfare ciò che non può essere soddisfatto, e cioè il desiderio della madre che è fondamentalmente incolmabile, il bambino si fa lui stesso oggetto dell’illusione materna: bisogna illudere quel desiderio materno, che non potrà mai essere soddisfatto. Ed è precisamente perché il bambino mostra a sua madre un’illusione, che si costruisce tutto il percorso attorno al quale si struttura l’Io.
Mi sembra chiaro che, come vi ho annunciato all’inizio, l’analisi dettagliata di Lacan riguardo ai tempi logici della costruzione della relazione d’oggetto nel bambino, dimostri con estrema precisione ciò che Winnicott enuncia riguardo alla fase della relazione d’oggetto: si tratta, come già detto, del momento in cui il bambino prende “le misure” della propria dipendenza e in cui modula la propria capacità di far sapere all’ambiente facilitante che ha bisogno di lui.
Ma torniamo alla relazione del bambino con la madre, nel punto in cui l’abbiamo interrotta.
In questo momento cruciale dello sviluppo, il bambino può diventare il miglior alleato del disconoscimento dell’Io da parte della madre, cioè il miglior alleato di una forma di disconoscimento da parte della madre che manca del fallo.
Per la madre può essere molto difficile dividere il proprio immaginario dal corpo reale del bambino, distinguere cioè il suo corpo e quello del bambino. Tale superposizione operata dalla madre è evidentemente catastrofica per il soggetto, perché rende impossibile l’articolazione al simbolico.
In assenza di sostegno e di comprensione sull’origine della profondità e dell’acutezza delle sue angosce esistenziali, il soggetto può arrivare a uno stato di disperazione tale da provare un sentimento di frammentazione che può portare, rigettato dall’inconscio, ad un passaggio all’atto o a un incidente brutale o a quello che possiamo chiamare un suicidio cammuffato.
Seconda parte: la posizione dell’analista.
Arriviamo ora alla posizione dell’analista sul comportamento da tenere durante la cura analitica.
Come riconoscere l’emersione dell’arcaico durante la cura?
Come abbordare e trattare le problematiche legate alla rimozione originaria?
Come circoscrivere i contorni di un sapere che, fin dall’origine, è fuori portata per il soggetto?
Cominciamo da Sandor Ferenczi che per tutta la vita ha cercato il modo di alleviare le sofferenze dei suoi pazienti con la psicoanalisi.
Nel suo Diario Clinico (gennaio-ottobre 1932) il 12 gennaio 1932 scrive: “ l’analista può entrare in contatto con “l’affetto rimosso”, solo con estrema difficoltà…Questa parte della storia del paziente si comporta come un bambino svenuto che non sa nulla di se stesso”.
A partire dal 1919, Ferenczi inventa prima la tecnica attiva che consiste a intervenire direttamente nella cura con dei gesti di tenerezza e di affetto, poi la tecnica dello scambio di ruoli in cui il paziente è invitato a dirigere la cura assieme all’analista.
Al di là delle critiche a queste ricerche di Ferenczi, assistiamo alla nascita di un’intuizione riguardo a una metodologia possibile per trattare l’emergere dell’arcaico nella cura, metodologia che Winnicott svilupperà in seguito non senza somiglianze con Ferenczi.
En 1924 Ferenczi pubblica Thalassa, saggio sulla teoria della genitalità dove sottolinea l’importanza capitale della ricerca sulle origini del legame arcaico madre-bambino.
Secondo Ferenczi, l’uomo ha certamente nostalgia del seno materno, ma, allo stesso tempo, tenderebbe, in alcuni casi, a una regressione verso la condizione fetale.
L’approccio alla psicoanalisi attraverso la metafora della cripta, è accompagnata da innovazioni tecniche.
“Qual è lo stato traumatico che l’ontogenesi ripete simbolicamente?” (Ferenczi, Confusion des langues, 1932)
In “La confusione delle lingue tra adulti e bambini” (durante il XII congresso di psicoanalisi), Ferenczi parla del ruolo della regressione nella tecnica attiva che ha dovuto mettere in pratica visti i fallimenti terapeutici o i risultati deludenti che aveva rilevato durante la cura di certi pazienti.
Ferenczi osserva che, tramite la sua tecnica attiva, da un lato c’è un certo miglioramento dei sintomi in alcuni pazienti, ma, dall’altro, prende nota dell’emergere di alcuni disturbi che corrispondono a ciò che io chiamo “l’arcaico nella cura”: stati di angoscia notturni, incubi dolorosi, crisi d’angoscia.
Ferenczi aggiungeva che il fatto di parlare dei suoi errori e di rinunciare a ciò che non aveva funzionato, gli faceva guadagnare la fiducia del paziente. Cito:” tale fiducia è quel qualcosa che stabilisce il contrasto tra il presente e un passato traumatico”
Ferenczi preconizza anche la benevolenza attiva dell’analista:” se questa benevolenza viene meno, il paziente si ritrova solo e abbandonato a un profondo sconforto, cioè nella stessa situazione insopportabile che l’ha portato, a un certo punto, alla scissione psichica e alla malattia”.
Nello stesso momento e parallelamente a Ferenczi, Mélanie Klein si interroga sul legame arcaico madre-bambino.
Ritorniamo alla pratica di Winnicott.
Winnicott sviluppa ciò che aveva imparato dalla Klein.
A ciò si aggiungeva la sua lunga esperienza di pediatra con neonati, bambini e genitori.
Qual’è la posizione di Winnicott nella cura delle “agonie primitive” dell’infans?
Come affronta le organizazioni difensive che queste angosce primitive hanno suscitato nel soggetto?
Ciò che Winnicott ci propone come ipotesi fondamentale è che “la paura clinica del crollo”, sintomo manifestato da alcuni pazienti, “sia la paura di un crollo di cui il paziente ha già fatto l’esperienza. Si tratta della paura dell’agonia primitiva che fu all’origne la responsabile dell’organizzazione difensiva che il paziente presenta come sindrome patologica”.
Winnicott ci indica che nella sua esperienza, tale patologia (quando esiste), non si manifesta all’inizio della cura. La paura del crollo non appare immediatamente. L’analisi può procedere per lungo tempo con successo prima che questa paura del crollo si manifesti.
Quindi, la paura del crollo, quando si manifesta, è la pura di un crollo che si è già verificato. Winnicott propone l’ipotesi che questo fatto sia “lontamente nascosto nell’inconscio” del soggetto, in un inconscio arcaico che per Winnicott non corrisponde all’inconscio freudiano. Proposito coerente con quello che Freud dice sull’esistenza di un narcisismo primario in quella fase arcaica in cui l’Io e l’Es non sono né costruiti né distinti l’uno dall’altro (e ancor meno il Super-Io).
Winnicott ci propone una forma di forclusione del trauma iniziale la cui rimemorazione è di stampo particolare dato che non si tratta di una censura da rimuovere.
La soluzione clinica di Winnicott propone all’analista di riuscire a creare le condizioni che gli permetteranno di dire al paziente che “il crollo (per il quale il paziente prova una paura che gli rovina l’esistenza), è già accaduto”. “Questo svolgimento finale è l’quivalente dell’emersione del rimosso, la perlaborazione, nell’analisi dei pazienti nevrotici”, ci dice Winnicott ne “La paura del crollo”.
Winnicott ritiene che la paura della morte può, in certi pazienti, corrispondere allo stesso schema.
E per rendere la cosa più esplicita, Winnicott fa l’esempio di una sua paziente di cui lui stesso non ha capito in tempo la situazione, e per chi la paura della morte ha avuto un esito tragico.
Questa paziente aveva già vissuto una forma di morte psichica in un’epoca arcaica, all’inizio della sua vita neonatale o persino durante la sua vita fetale.
“La morte – se la si considera come un qualcosa che succede al paziente quando è troppo immaturo per farne davvero l’esperienza, prende il senso di un annientamento” (Winnicott pagina 213).
Se avesse capito in tempo, Winnicott avrebbe potuto dire alla sua paziente “che era già morta nella sua prima infanzia”, e che dirle ciò avrebbe impedito la fine tragica dell’analisi, cioè il suicidio della paziente.
Questo lavoro lo portò a cercare la posizione analitica più consona per curare dei pazienti come Margareth Little le cui “angosce erano di tipo psicotico”.
Margareth Little (psicanalista inglese del Middlegroup) parla della cura con Winnicott nella sua raccolta di scritti apparsa con il titolo di “Gli stati-limite”.
Quando Margareth Little arriva da Winnicott ha 48 anni e ha già fatto due analisi. Resterà con Winnicott dal 1949 al 1957.
Margareth Little scrive che la sua “psicosi aveva origine nello stato di caos organizzato da sua madre, prima e dopo la sua nascita”.
“Il mio delirio si fondava sulla convinzione che io vivessi in uno stato di Unità totale con mia madre, nella sua identità, in una continuità che le era propria e che io poi trasferii su Winnicott con tutta l’ambivalenza che il transfert implicò: lui era per me, in senso letterale, l’utero di mia madre.”
“ Questo non mi impedì di accorgermi delle schegge di verità che ogni delirio contiene. Con mia madre era esistita una continuità rele, genetica e , durante la vita prenatale, anche fisica attraverso la placenta e le mebrane. Dopo la nascita c’era stato un contatto fisico che aveva dato adito a delle percezioni e a una forma di relazione limitata”
Margareth Little ci mostra che l’angoscia “impensabile” o “arcaica” è provocata da traumi contro cui il soggetto non possiede difese organizzate, dando luogo quindi a uno stato confusionale.
Tale stato confusionale è vissuto come una distruzione totale, come una caduta senza fine, come l’assenza di ogni mezzo per comunicare con l’altro, suscitando un sentimento di isolamento assoluto che si esprime con percezioni come l’assenza di legame col proprio corpo oppure la sensazione di essere perduto nello spazio.
Dopo un periodo di osservazione e di pratica, Winnicott capì che la psicosi era una “malattia dovuta ad una inadeguatezza (carenza, deficit) dell’ambiente facilitante” e che esigeva, per essere curata, una regressione al periodo in cui l’adeguamento o la carenza dell’ambiente facilitante erano state di un’importanza capitale. Bisognava che il paziente potesse rivivere e riattualizzare gli eventi di quel periodo e che l’analista diventasse per lui l’ambiente facilitante capace di “adattamento attivo totale durante tutto il tempo necessario per in seguito sostenerlo nel processo di disadattamento progressivo (il ritorno alla vita normale).”
Winnicott considerava giustamente che l’esercizio di questo tipo di tecnica nella cura analitica fosse particolarmente faticoso per l’analista.
Parlando di queste problematiche traumatiche, profonde e inacessibili, ci viene in mente la topologia di un oggetto fisico: il buco nero.
Tra l’altro è anche il titolo del libro di Frances Tustin sulle barriere autistiche nei nevrotici.
Un buco nero, è una zona dell’universo da cui nulla può tornare indietro e che è collegata al resto dell’universo da un contorno (margine). Il buco nero manifesta la propria esistenza con effetti potenti e bizzarri. Per esempio, così come lo specchio curvo tanto caro a Lacan, il buco nero ci rimanda, quando guardiamo nella sua direzione, alle immagini e agli anamorfismi degli oggetti celesti che ci circondano.


