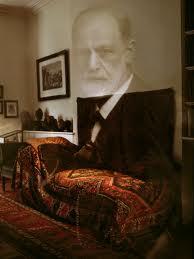
30 Mar Primum non Nocere – di Eckhard Bär
Pubblichiamo il testo dell’intervento nel corso delle Giornate Europee di Maggio 2004, dal titolo: La cura psicanalitica è una terapia efficace? Eckhard Bär è psicanalista a Kassel (Germania)
di Eckhard Bär
La questione posta dal tema di questo congresso “LA CURA PSICANALITICA E` UNA TERAPIA EFFICACE?” ha diversi aspetti e non è facile rispondervi. La questione contiene implicitamente la premessa che una terapia efficace esista. In che cosa consisterebbe questa efficacia e di quale terapia si tratta? Immagino che la terapia alla quale qui ci si riferisce sia il trattamento farmacologico e la psicoterapia.
In che cosa la psicanalisi sarebbe efficace? Ha altri effetti o effetti paragonabili a quelli di questi ultimi?
Gli psicofarmaci hanno, fin quando dura il loro effetto fisiologico, l’efficacia di calmare o di eccitare e di cambiare un sintomo; a volte aiutano a superare uno stato di crisi. Contrariamente a quello che affermano la medicina e le industrie farmaceutiche, una volta smessa la loro assunzione, la loro efficacia riguardo al cambiamento della struttura di una sintomatologia è più che dubbia come viene dimostrato per esempio dagli antidepressivi. Da questo punto di vista i loro effetti sono paragonabili alla suggestione, suggestione che fu abbandonata da Freud perché la sua efficacia durò spesso solo il tempo del rapporto con l’ipnotizzatore.
Nella sua conferenza del 1966 “PSICANALISI E MEDICINA” Lacan dice che il medico, in aggiunta al ruolo professionale che gli è proprio, viene investito, dal mondo scientifico e dalle organizzazioni industriali, del ruolo di agente di distribuzione di medicinali ed una miriade di nuove sostanze chimiche di terapia vengono messe nelle sue mani per essere sperimentate. Questo è uno sviluppo che mette, sempre di più al centro dell’interesse, il diritto dell’uomo alla salute e che, attraverso il potere che si lega a ciò, dà a tutti la possibilità di “…venire dal medico … e pretendere di ottenere da lui… la propria <guarigione> (il proprio benessere)…” “venir demander au médecin son ticket de bienfait dans un but précis et immédiat, nous voyons se dessiner l´originalité d´une dimension que j´appelle la demande.” Lacan poi prosegue “… rispondere che il malato viene da noi con la richiesta di guarigione significa non rispondere niente poiché… vi è, al di fuori di ciò che viene (s)cambiato con il bene terapeutico, qualcosa che rimane costante…” “repondre que le malade vient vous demander la guérison n´est rien repondre du tout… il y a hors du champ de ce qui est modifié par le bienfait thérapeutique quelque chose qui reste constant…” Con l´indicazione “che se qualcuno viene a chiedere qualcosa, questo non è affatto identico con – anzi a volte è diametralmente opposto a – ciò che desidera” “lorsque quiconque nous demande quelque chose ce n´est pas du tout identique et méme parfois diamétralement opposé à ce qu´il désire…” Lacan introduce qui quello che chiama la struttura della fenditura la structure de la faille qui existe entre la demande et le désirche esiste tra la domanda ed il desiderio. Questo può implicare che in tutto e per tutto il malato rimane attaccato all’idea di tenersi la propria malattia e di essere un malato ben installato.
In “TELEVISION” Lacan risponde ad una domanda sulla guarigione: “La guarigione è una richiesta che parte dalla voce del sofferente… Ciò che stupisce è il fatto che esiste risposta e che da sempre la medicina ha fatto centro con delle parole.” Questo era prima che fosse scoperto l´inconscio e se ne può dedurre che “una prassi non deve essere illuminata per funzionare”.
Far centro con le parole è il campo della psicanalisi ma anche la psicoterapia si muove nell’ambito del linguaggio, della parola. Quello che vorrei cercare di dimostrare qui è che le due non hanno la stessa direzione; per la comprensione di quel che segue devo ricordare che in Germania, anche in seguito alla cosiddetta “analisi delle casse”, cioè pagata dalla propria cassa assistenziale, il più delle volte psicanalisi e psicoterapia non vengono più distinte.
Allora, che ne è della psicoterapia riguardo alla questione posta all’inizio? Non si può forse dire in generale che la psicoterapia è caratterizzata dall’accettazione della richiesta di eliminare dei sintomi? Visto che fa proprio dell’appagamento di questa richiesta il suo scopo dichiarato ed il criterio della sua efficacia é a tal punto questo che ammette dei “controlli di efficacia”. Ma in che modo può realizzare tutto questo? E: l’efficacia si misura veramente con l’eliminazione dei sintomi? Perché la psicoterapia può consistere in un supporto consolatore, in un coprire e spostare alcuni sintomi. E direi che la guarigione rivendicata dalla psicoterapia consiste in gran parte in un coprire ciò che per l’essere umano non va, rispetto al reale. E` in questo senso che la psicoterapia fa parte di una tradizione: la religione, le cui promesse funzionano in questo modo.
Ma che cosa è che in fin dei conti spinge qualcuno a trovare un analista od uno psicoterapeuta per chiedergli di ottenere qualcosa che chiama “salute” soprattutto visto che i sintomi gli procurano pur tuttavia e per le vie del dispiacere un soddisfacimento? Basta la sofferenza causata da un sintomo per iniziare un´analisi? O forse ci vuole accanto il desiderio “WUNSCH” di non continuare a vivere così, con questa sofferenza, è anche e soprattutto una domanda di soggettivizzazione che spinge a ciò (che là in quel luogo dà tormento?), la supposizione di essere soggetto di un inconscio. Se il desiderio di ottenere un cambiamento con l’aiuto della psicanalisi è penetrato dalla questione (dal desiderio di riconoscimento) per il senso sconosciuto delle proprio azioni, colui che in tal modo si mette alla ricerca può compiere una svolta. Così la sua posizione si distingue da quella di un malato che dall’altro richiede una guarigione. Spesso la situazione iniziale di un trattamento è contraddittoria nel senso che vengono espresse delle ragioni ed intenzioni consce mentre i veri fattori inconsci sono tutt’altro ed addirittura opposti. Così può essere che qualcuno viene con la richiesta di salvare il proprio matrimonio minacciato da un sintomo; a volte ci vogliono solo pochi passi di analisi perché venga fuori che si tratta dell’esatto contrario di ciò che inizialmente richiedeva: non il ristabilimento ma la dissoluzione del matrimonio.
Questo significa che l’orientamento dell’analisi cosiddetta terapeutica verso l’eliminazione di sintomi può condurre l’analisi in una posizione distorta. Se il sintomo viene privilegiato rispetto al desiderio questo crea delle condizioni precarie per il desiderio nell’analisi. Se l’analista all’inizio della cura accetta un patto con le intenzioni consce di eliminare un sintomo manifesto, l’analisi può entrare in contrasto con il desiderio inconscio – essenziale per l’analisi – e diventare impossibile. Sin dalla sua nascita la psicanalisi si fonda sull’impossibilità di poter stabilire una connessione fissa tra il modo di manifestarsi di un sintomo ed il desiderio inconscio che ne sta alla base. E´ in questo che si distingue dal discorso corrente della medicina, della psichiatria e della psicoterapia.
La psicoterapia finanziata dalle casse assistenziali rappresenta un tale patto e che, per di più, deve essere confermato da una perizia, da un terzo rappresentante della comunità sociale; ciò è doppiamente problematico perché nella relazione per il perito devono essere fatte delle affermazioni e delle definizioni su qualcosa che può, comunque, solo apparire nel corso del lavoro, del trattamento. Ignorare questa contraddizione porta alla simulazione di una realtà erronea, anzi, si tratta di un inganno al fine di raggirare per ottenere un vantaggio economico, sul quale é basato il patto della cura. Si può dire che uno psicanalista che all’inizio del trattamento fa delle affermazioni definitive riguardo alla struttura del conflitto psichico, al fatto che qualcuno sia atto all’analisi e che ci siano delle possibilità di successo, agisce con presunzione prendendo le parti di una struttura fantasmatica, in altre parole, egli abbandona la posizione della cosiddetta neutralità analitica.
Con questa psicoterapia che in parte si vende sotto il nome di psicanalisi gli psicanalisti si sono comprati l’alimentazione attraverso la società (il mantenimento dalla società) dando ad essa l’assicurazione che la nevrosi non sia “una malattia causata da desiderio” (!) WUNSCHBEDINGT. La terapia di malattie “condizionate da desiderio” era stata esplicitamente esclusa dalla REICHSVERSICHERUNGSORDNUNG – l´ordine delle assicurazione del REICH (!) – il sistema attuale delle casse di assistenza sanitaria é stato fondato in base a queste disposizioni tuttora vigenti. In questo modo, per esempio, il desiderio isterico fu definito malattia e quindi escluso, in quanto momento fruttuoso, dal lavoro analitico poiché là dove l’unico scopo da raggiungere è un essere normale, il desiderio fa piuttosto scandalo. Il termine, la fine di tali terapie, in Germania spacciate per psicanalisi, viene poi determinato dal numero di sedute pagate dalla cassa. Queste “analisi delle casse” sono la norma mentre le analisi pagate di tasca propria sono l’eccezione.
Al contrario di questa prassi di psicoterapia, la psicanalisi non può essere orientata nel senso di un’eliminazione dei sintomi. Per la psicanalisi il sintomo non è il segno di un difetto, di un troppo che deve essere eliminato bensì è segno della rimozione, segno di un desiderio. Freud, in quanto allievo diligente dell’isterica ha decifrato sintomi, sogni, atti mancati e addirittura I WITZE – i motti di spirito – come un messaggio cifrato. Ha reso possibile l’annodamento del segno con il significante ed ha così messo in opera una traduzione che dimostra che il godimento consiste in “impasse” logici. Il tentativo di eliminare questa traccia testimone del reale seppellirebbe proprio ciò che vi è di più prezioso. Impedirebbe l’avvicinamento al campo del reale nel quale l’analista accompagna l’analizzante per raggiungere una frontiera oltre la quale egli possa cogliere il suo desiderio. Questo è un campo che gli psicoterapeuti non amano visitare ed una frontiera davanti alla quale la terapia indietreggia. La psicanalisi non è primariamente un metodo di guarigione, non è un procedimento efficace per la diagnosi e l’eliminazione di disturbi. In essa si tratta del fatto che la parola prosegua, cioè continui e vada oltre, affinché che nel posto lasciato vuoto dal sintomo possa emergere un desiderio nuovo che, se riesce a liberarsi dalle sue inclusioni di identificazione, può, poi, essere riconosciuto.
Questo può anche significare poter vivere, con-vivere con il proprio sintomo; vivere senza aver ottenuto o dover ottenere per questo una conferma o un incoraggiamento da altri.
Ad un collega che, tempo indietro, affermò: “Si può dire quel che si vuole – la psicanalisi è pur sempre un metodo di guarigione!” ho replicato che la psicanalisi nella sua specificità non è un metodo – e soprattutto non un “metodo di guarigione”. Proprio perché (in essa)si può “dire quel che si vuole” non è un metodo, non è un procedimento pianificato, costruito su un sistema di regole fatte per raggiungere conoscenza o risultati pratici. La psicanalisi si basa su una regola, “dica tutto quel che vuole, non importa, che cosa sia…” e su un contratto tra due, nel quale la parola sarebbe il terzo. Non è metodo nel senso detto prima, ma lo è nel senso del greco : “seguire il cammino, la via per, verso qualcosa” con il particolare che non sa cosa sia questo qualcosa né verso dove vada. E´ proprio questo che la distingue dalla psicoterapia, la quale crede poter identificare il sintomo nella sofferenza che ne sta alla base. La psicanalisi funziona piuttosto “metá-hodòs” dopo, oltre il cammino, nel senso che un cambiamento può aver luogo dopo, poi (in più),NACHTRÄGLICH é come un “in più” un supplemento.
In questo senso vorrei rispondere alla domanda di questo congresso: la psicanalisi può essere efficace solo in quanto non cerca di essere una terapia efficace!
E` proprio per quanto riguarda l’“in più” la NACHTRÄGLICHKEIT che mi sono imbattuto in un passo della “Proposition du 9. Octobre 1967” di Jacques Lacan che si riferisce alla connessione tra psicanalisi e psicoterapia e dal quale ho preso in prestito il mio titolo PRIMUM NON NOCERE. Lacan vi dice che la formazione dell’analista viene costituita dall’esperienza originaria della psicanalisi che è da spingere fino al punto di “rappresentare la finitezza FINITUDE di questa esperienza… per rendere possibile la sua NACHTRÄGLICHKEIT (il suo après coup) il suo poi: un effetto di tempo che, come si sa, è ‘radicale’ per la psicanalisi.” (“DE CONSTITUER LA PSYCHANALYSE COMME EXPERIENCE ORIGINALE; DE LA POUSSER AU POINT QUI EN FIGURE LA FINITUDE POUR EN PERMETTRE L`APRES-COUP – EFFET DE TEMPS, ON LE SAIT, QUI LUI EST RADICAL) E Lacan sottolinea poi “…che non esiste alcuna definizione possibile del terapeutico, se non quella di essere il ristabilimento di un primo stato; una definizione che per l’appunto è proprio impossibile porre per la psicanalisi.” (… IL N`Y A AUCUNE DEFINITION POSSIBLE DE LA THERAPEUTIQUE SI CE N`EST LA RESTITUTION D`UN ETAT PREMIER: DEFINITION JUSTEMENT IMPOSSIBLE A POSER DANS LA PSYCHANALYSE) Per quanto riguarda l’impossibilità del ristabilimento di un primo stato, bisogna ricordare la rimozione originaria, le diverse scritture della memoria descritte da Freud, la relazione tra S1 a S2 di Lacan e ciò che la psicanalisi intende con la castrazione. Di fronte a tutto questo, la restituzione di un primo stato tiene conto di un concetto di sintomo inteso come difetto, disturbo di un campo chiuso ed ideale della realtà senza beanza, fenditura, campo che si tratta di ri-raggiungere seguendo un’ideologia di attuabilità.
Poi Lacan – sempre nella “Proposition” – si riferisce al “primum non nocere” – primo: non nuocere –
e fa la seguente osservazione: “…(se) il primo non può essere stabilito all’inizio: come si può ponderare che cosa sia il non nuocere!… Si può trovare il tempo girato in senso contrario, là dove ciò a cui si trattava di non nuocere era il quadro clinico.” (IL PRIMUM NON NOCERE… NUIRE! DE NE POUVOIR ETRE DETERMINE PRIMUM AU DEPART: A QUOI CHOISIR DE NE PAS NUIRE! ESSAYEZ! IL EST TROP FACILE DANS CETTE CONDITION DE METTRE A L`ACTIF D`UNE CURE QUELCONQUE LE FAIT DE N`AVOIR PAS NUI A QUELQUE CHOSE… ON PEUT TROUVER LE TEMPS REVOLU OU CE A QUOI IL S`AGISSAIT DE NE PAS NUIRE; C`ETAIT L`ENTITA MORBIDE….”: Lacan conclude questo passo con l’osservazione “che è troppo facile mettere all’attivo di ogni cura il fatto di non aver nuociuto ad una cosa” e con il sottolineare l’importanza dell’inizio e della fine per la psicanalisi, di cui inizio è il transfert.
Ora, questo “primum non nocere” in quanto principio dell’etica dell’agire medico sembra dapprima abbastanza comprensibile per il “sano intelletto umano” e viene messo in burla nel detto “operazione riuscita, paziente morto”. Tenendo conto di tutta la tragicità degli scandali e deragliamenti in questo campo che vengono quasi ogni giorno riportati dalla stampa, bisogna notare che nella quotidiana prassi medica esistono un’infinità di misure che, come si dice, “buttano via il bambino con l’acqua sporca”, voglio dire che lo sforzo di far sparire un sintomo può condurre ad effetti collaterali terrificanti.
Allo stesso tempo e basandosi su questo principio un’organizzazione industriale della salute ha sviluppato un astruso modo di pensare in termini di sicurezza e garanzia che porta a tutte quelle inutili misure di esami e trattamenti messi in atto per escludere la pur minima possibilità di un sospetto. Se in questo modo vengono capitalizzati il narcisismo e la paura della morte, il nostro sistema di sanità pubblica minaccia di crollare sotto i costi causati da tale misure. Così, per presunte ragioni di efficacia, il soggetto viene sempre più sloggiato attraverso un enorme spezzettamento dei trattamenti per cui ogni singolo sintomo viene trattato da uno specialista dichiarato responsabile per esso. Questo modo di pensare ha un importante influsso sul campo delle psicoterapie e si ritrova nelle corrispettive leggi e disposizioni. E’ la paura davanti a conseguenze giuridiche che mantiene in vita questo circuito. In questi trattamenti si sente letteralmente la presenza di un “terzo” che sorveglia e controlla che le misure ritenute “giuste” siano applicate.
Questo tipo di influsso è impossibile nella psicanalisi che, come osserva Freud, non supporta alcun “terzo”. Lo psicanalista può, nel suo ascolto, nel suo interpretare, e nel suo atto rimettersi solo all’inconscio e non può per questo attenersi a pretese regole. Baderà tuttavia a che il parlare – e questo implica sia la vita che il desiderio – possa continuare.
Sarebbe forse questo, il suo modo del primum non nuocere ?


